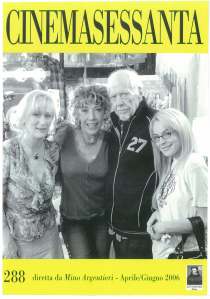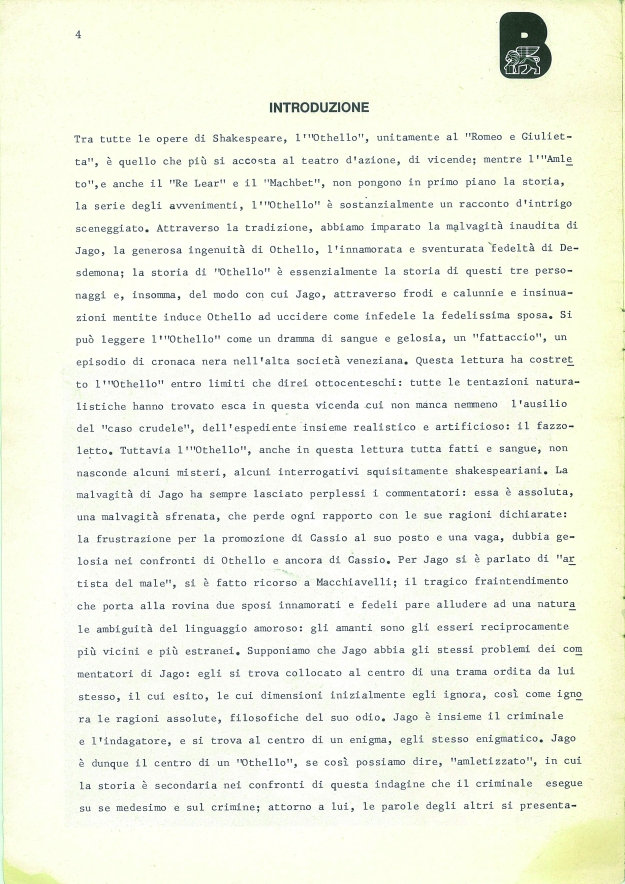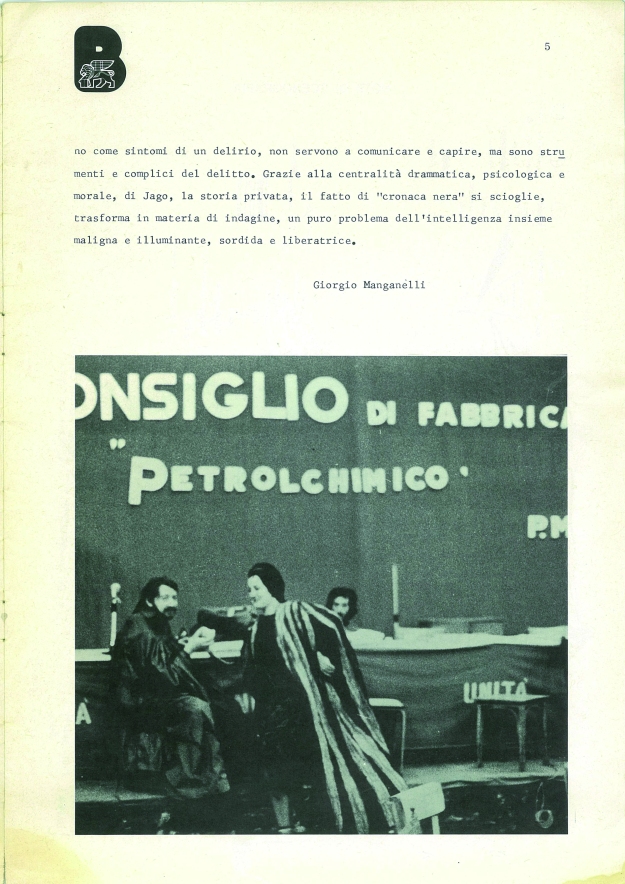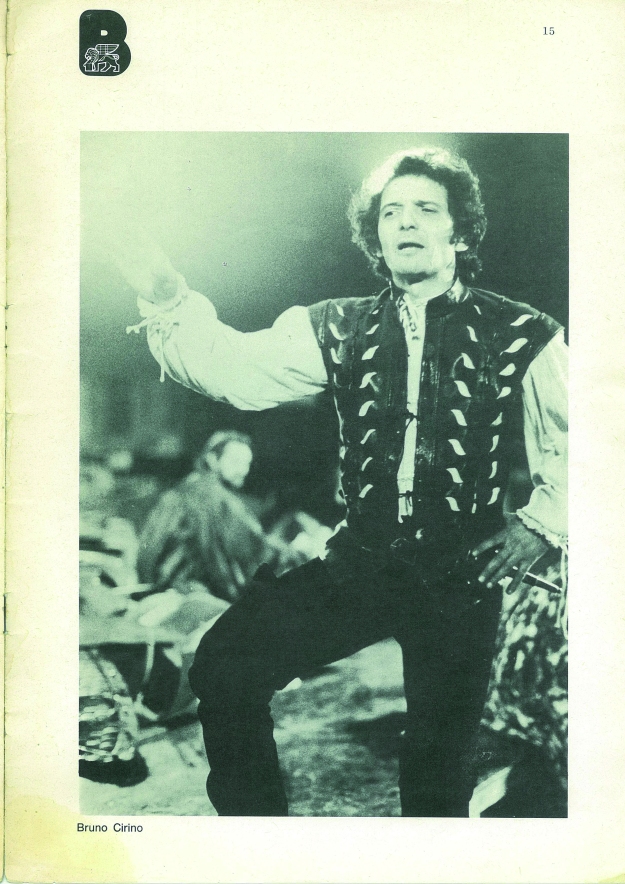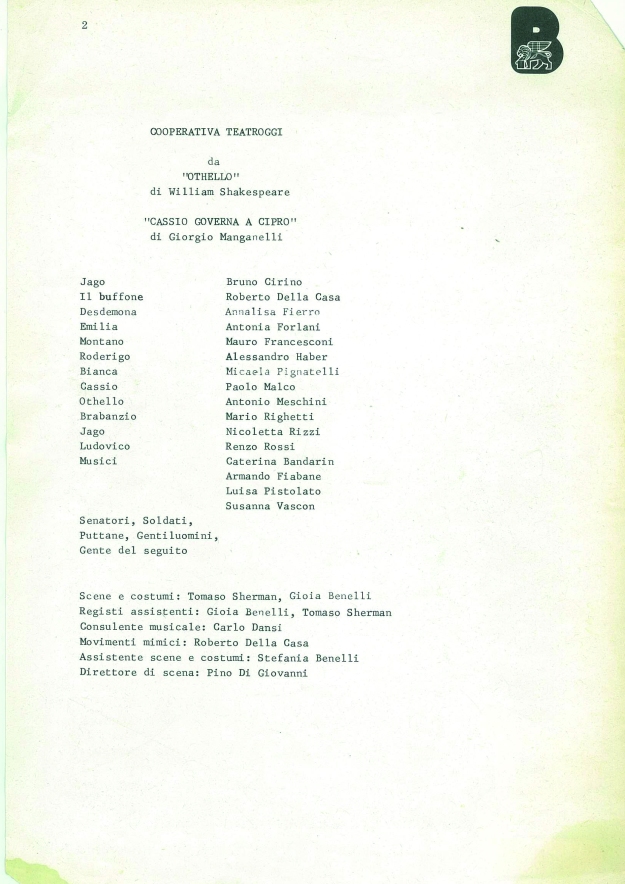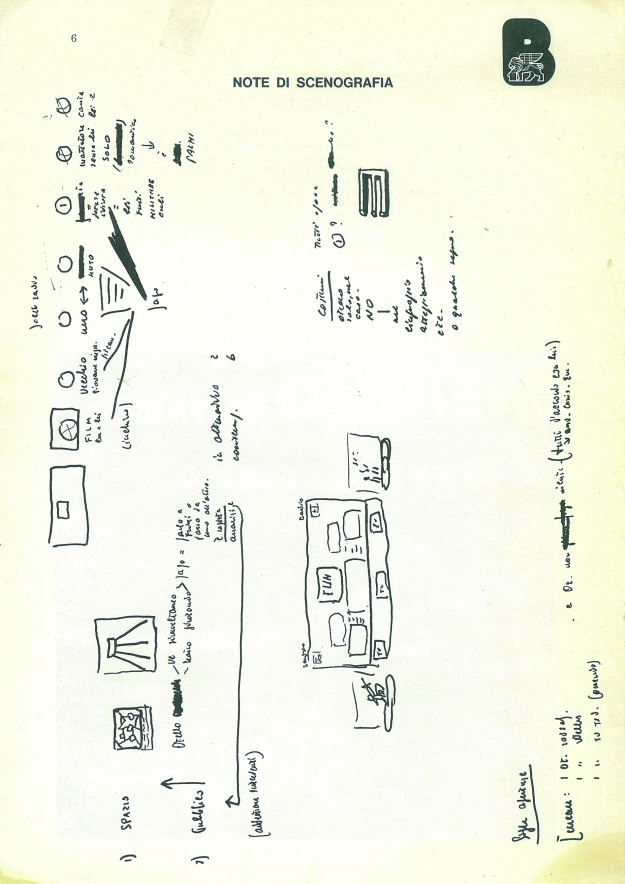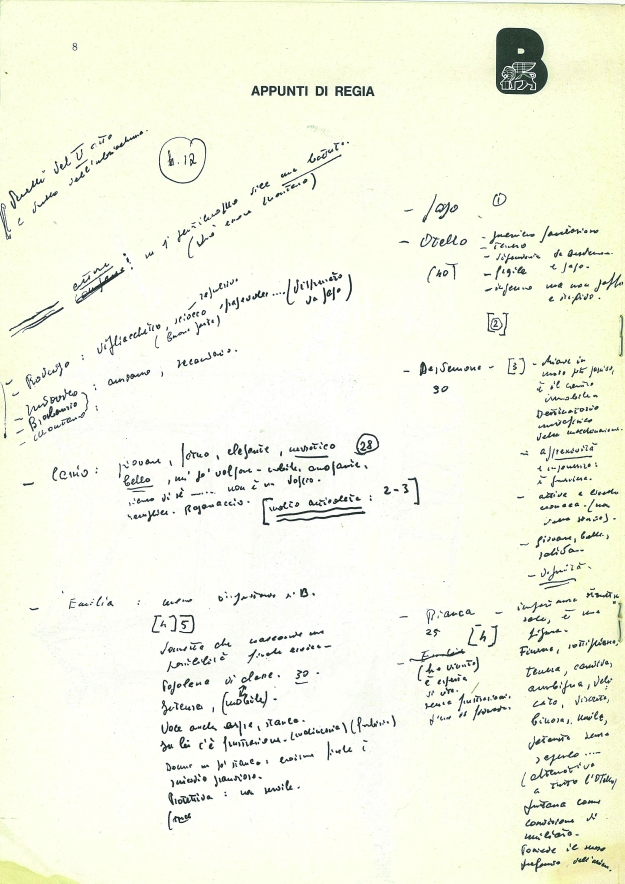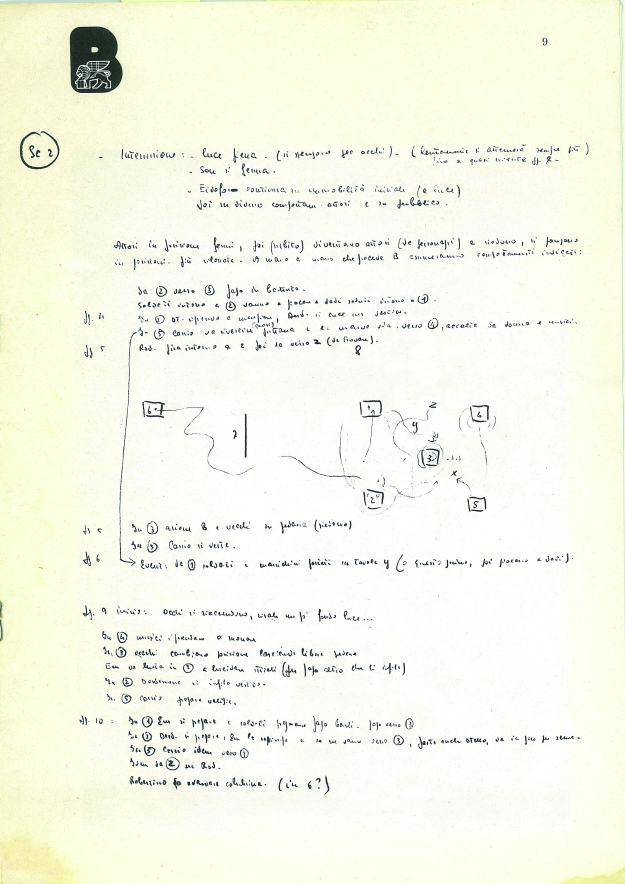TESI DI LAUREA
DI
GILDA CIAO
Presentata alla Normale di Pisa
Cassio governa a Cipro
La parola e la scena
PER VISUALIZZARE CLICCA SUL TITOLO CHE SEGUE
IL TESTO CHE SEGUE – DI MAURIZIO MASSABO’ – PUBBLICATO SU CINEMASESSANTA
RIPRENDE TEMI DELLA TESI DI GILDA CIAO
E APPARE NON CASUALMENTE ANCHE NEL CAPITOLO BLOG
“I PUNTINI SUGLI I”
LEGGETE SOTTO IL TESTO IN CHIARO, OPPURE CLICCATE SUL TESTO ORIGINALE:
Storie e memorie della Biennale “riformata”(1974)
Quando si faceva la rivoluzione
con l’ “Othello” di Shakespeare
Ronconi, Manganelli, Perlini, Jancsό, Cirino, Pagliarani, Arbasino, Augias, Carmelo Bene, il Gruppo ‘63 e Gianni Serra: avvenimenti e polemiche di ieri e di oggi
di Maurizio Massabò
1974 in Italia: anno segnato da eventi drammatici e, al tempo stesso, dalla presenza di speranze di massa e dallo svolgersi di avventure intellettuali che erano la sintesi di altre avventure, sperimentalismi, ricerche e battaglie appassionate, ma anche di delusioni, fallimenti, abbandoni di campo. A maggio scoppia la bomba in Piazza della Loggia, ad agosto scoppiano quelle sul treno Italicus, per dire soltanto di due degli eventi maggiori che marcarono quell’anno, in una guerra tra bande nere e rosse, ma anche tra servizi segreti di mezzo mondo, polizie, politici e poteri forti. E, insieme, ci furono fatti positivi, anche se qualitativamente molto diversi e non paragonabili con gli altri, ma figli indiscutibili dello stesso tempo, come l’apertura del sipario sulla riforma democratica della Rai, che sarebbe stata votata in Parlamento di lì a pochi mesi, e l’avvio della cosiddetta “Biennale riformata”, ovvero della nuova istituzione veneziana a vocazione internazionale, riscritta da una legge del ’73, che sembrava raccogliere in sé la summa e la scrematura dei movimenti di battaglia culturale e di riorganizzazione delle forme e delle procedure del fare e del recepire cultura. Un processo avviatosi negli anni sessanta, che si sarebbe concluso nell’arco dei settanta.
Il Direttore della Biennale è quell’anno Carlo Ripa di Meana e il lavoro progettuale è affidato a sei commissioni di lavoro e a due gruppi permanenti. Le commissioni si occupano di arti visive, architettura e territorio, cinema e spettacolo televisivo, teatro e musica, informazione e mezzi di comunicazione di massa. I due gruppi si occupano l’uno dei convegni e l’altro dei rapporti con la scuola. La commissione del teatro è composta da Peter Brook, Bernard Dort, Natalia Ginzburg, Gian Renzo Morteo, Mario Raimondo e segretario ne è Paolo Radaelli. Ed è di teatro che voglio soprattutto parlare in questa memoria, per l’interesse obbiettivo del tema (quell’anno la sezione teatrale fu in qualche modo lo specchio di esperimenti ed azioni previsti, auspicati ed esercitati dal “movimento” culturale del tempo) e per le polemiche che torna a suscitare ancor oggi, ora per la ricostruzione di quella che potremmo chiamare la filologia degli eventi e ora per il recupero di alcune verità storiche. E’ su questi aspetti che abbiamo dialogato con Gianni Serra, regista di cinema e di televisione (1), che in quel segmento della Biennale svolse un ruolo da protagonista.
Il “comunista” Ronconi
Luca Ronconi (2) fu nominato nel ’74 direttore della sezione Teatro e Musica.
Scrive Carlo Ripa di Meana: “ (C’è stato) un rifiuto nei fatti, oltre che nelle dichiarazioni unanimi del Consiglio direttivo, della pratica degradante della spartizione partitica dei settori di lavoro: con la nomina alle direzioni di intellettuali e artisti come Ronconi, Gregotti e Gambetti ”.
Davvero quella convenzione lottizzatoria fu rotta e soprattutto quella Biennale fu vissuta dagli intellettuali e dalla stampa come un reale distacco dalle pratiche spartitorie?
Serra non è d’accordo: “Quello era il primo incarico istituzionale di Luca e suscitò negli ambienti reazionari e conservatori una reazione compatta e in alcuni casi violenta. A questa però si aggiunse un atteggiamento fortemente critico di vari intellettuali che erano appartenuti a un gruppo di una certa importanza nella cultura italiana, il Gruppo‘63 (3). Uomini di sinistra, questi ultimi, ma che con il Partito comunista e le sue politiche culturali erano, per lo più, in forte disaccordo. Lo furono anche di fronte a Ronconi che dal Pci era stato perlomeno segnalato per quell’incarico. Le iniziative politiche di quell’anno fecero dunque parlare di egemonia comunista.”
Il Pci non era al governo, ma la strategia politica del compromesso storico, dell’accordo coi cattolici, era già stata elaborata. Fu elaborata nel 1973 da Berlinguer, anno in cui iniziò anche la presa di distanza del Manifesto. Il vento di quegli anni, e non solo nelle iniziative culturali, tirava dunque fortemente a sinistra, e i militanti comunisti avevano un peso, soprattutto per il loro impegno, e una indiscussa autorità.(4).
D’altra parte il teatro in particolare era investito da qualche anno non da un vento, ma da una vera e propria tempesta di rinnovamento: dalle cantine romane e milanesi alla ricerca di spazi e di pubblici nuovi, dalla formazione delle cooperative alla scelta dei referenti internazionali, dall’esplodere di forme varie di teatro all’apparire sulla scena di teatranti senza confini, un po’ attori e un po’ registi, un po’ imbonitori e un po’ tecnologi, un po’ capocomici e un po’ autori visionari. Ronconi si collocava in questo quadro come un innovatore e in alcuni casi un rivoluzionario, ma pur tuttavia uomo d’ordine e di “sistema”, che introduceva in quel guazzabuglio di umori, di passioni, di speranze e di sogni che era il teatro e che fu la Biennale di allora la “giusta dose” di sperimentazione, di rinnovamento e di una cultura specchio del tempo, senza violentare per questo l’istituzione, anzi offrendo a tutti il massimo di garanzie. Artista di lotta e di governo, verrebbe voglia di dire, e in questo senso più vicino ai comunisti che ad altri della galassia di sinistra.
Dice Serra: “La nomina non piacque a destra, ma del tutto neppure a sinistra, quella più radicale. Il suo progetto teatrale fu criticato, ad esempio, da una parte dei militanti de il manifesto, soprattutto da quelli della sezione veneziana, che si considerò “emarginata” da ogni iniziativa-Biennale, nonché, come dicevo, da molti del Gruppo ‘63, anche se alcuni di loro si ritrovarono poi coinvolti come autori o spettatori critici della Biennale ‘74. Parlo di Nanni Balestrini, che fu invitato a scrivere un testo per un’operazione che poi non ebbe seguito e non per colpa sua, o di Elio Pagliarani che lavorava allora per Paese Sera e che seguì le differenti manifestazioni in qualità di critico o infine di Giorgio Manganelli che stese il copione del mio spettacolo. Quelli di loro che fecero un’opzione politica si schierarono con i cosiddetti “gruppettari”. Persino Angelo Guglielmi fu più gruppettaro di altri. Nel ‘68 partì per andare a Parigi a “vedere” o a “fare” la rivoluzione, non so bene, ma non arrivò neppure alla frontiera a causa di un incidente d’auto. Però questa è ovviamente un’altra storia. Comunque sia, la nomina di Ronconi, per lo spessore dell’uomo e del regista, fu un fatto di grande importanza”.
Tre (anzi due) “Otello” in campo
La Sezione Teatro del ’74 si svolge in un arco di tempo molto ampio per un festival, dal 5 ottobre al 9 novembre, nel territorio veneziano e circostante, in dieci sedi diverse, con la presentazione di 44 manifestazioni teatrali. Ronconi, per quanto riguarda la partecipazione italiana, fa, tra le altre, una scelta originale: tre spettacoli in tre serate diverse, in luoghi diversi, ma su testi derivati tutti – o riscritti o reinterpretati, se si vuole – da un unico copione, l’“Otello” di Shakespeare, un lavoro scritto dall’inglese nel 1604 e che fa parte del cosiddetto “quarto gruppo” delle sue opere (“Amleto e “Re Lear”, tra queste). Perché fu fatta la scelta dell’“Otello”? nessuno ha dato una risposta esauriente a questo interrogativo, ma è facile pensare a tre motivi: si tratta di un dramma fortemente popolare e ampiamente conosciuto, anche per la sua versione verdiana e per quelle cinematografiche (Orson Welles in particolare); è al tempo stesso un dramma classico e colto; c’è un’ambientazione (quella iniziale) e ci sono personaggi legati a Venezia. Forse se la Biennale si fosse tenuta a Verona Ronconi avrebbe scelto “Romeo e Giulietta”.
L’ideazione e la realizzazione del trittico fu affidata a tre registi particolarmente noti, sia pure in ambiti diversi. La proposta fu avanzata all’ungherese Miklόs Jancsό, un grande regista cinematografico, per il quale era pronto un adattamento curato da Nanni Balestrini. Poi Jancsό (trasferitosi a Roma nel 1972) dette forfait per un serie di impegni sopravvenuti e il trittico si ridusse a due affidamenti soltanto. Comunque alcune voci riportarono che Jancsό avrebbe voluto introdurre con forza, nella sua rappresentazione, l’elemento cinematografico.
Altro invito fu per Memè Perlini, regista teatrale – solo in seguito realizzerà film – che in quegli anni si era imposto sulle scene dell’avanguardia italiana, e romana in modo particolare, per il suo ingegno, la sua logica visionaria dello spettacolo, per la sua blasfemia rispetto alle convenzioni e tradizioni del teatro ufficiale, per le sue innovazioni. Perlini curò da sé il testo (soltanto appunti, secondo il suo stile) su cui lavorare. Lo spettacolo, realizzato dal gruppo “La maschera” di Roma (5) iniziava prima che gli spettatori entrassero in sala. All’ingresso un narratore raccontava la storia del Moro e i fatti della sua tragedia, poi si accedeva a un lungo corridoio buio dove c’era una ragazza dormiente e, infine, si entrava nel grande spazio centrale carico di oggetti, corpi nudi o seminudi, granchi, piatti, vestiti, ornamenti e altro ancora. In un angolo c’era Otello, un negro alto, magrissimo e nudo, rannicchiato su se stesso. E cominciava lo spettacolo. Il tutto fu in scena dal 3 al 9 novembre, nella Chiesa cinquecentesca sconsacrata di San Lorenzo.
Il terzo incarico andò al milanese Gianni Serra, regista televisivo e cinematografico, ma con predominante esperienza televisiva. Cinematograficamente già noto per “Uno dei tre” (1972), e per la diffusione in circuiti alternativi anche non italiani, in vari circoli del cinema, in festival internazionali, di opere televisive trascritte e “lavorate” su pellicola, come “La rete Jeanson” (acquisita, con altre sue realizzazioni, nel Patrimonio Langlois della Cinémathèque di Parigi), noto in particolare, in seguito, per “La ragazza di Via Millelire” (1980), Gianni Serra era una delle firme più importanti della Rai-Tv di allora.
“Mi telefonò Ronconi, racconta Serra, per propormi la realizzazione teatrale di un “mio” Otello, da fare in piena libertà. Naturalmente mi espose il suo progetto, di come intendesse far confrontare al pubblico tre realizzazioni di uno stesso testo in spazi non convenzionali, dando questo mandato ad autori di derivazione diversa, ma accomunati da uguale interesse professionale nella sperimentazione di nuovi linguaggi, fuori dalle convenzioni tradizionali. Luca conosceva le mie sperimentazioni televisive e cinematografiche, l’utilizzo, per esempio, del montaggio cinematografico per il materiale televisivo dei miei lavori Rai. E mi sollecitò a sfruttare queste linee di ricerca anche in teatro. Ma – caso più unico che raro, per civiltà e rispetto nei confronti altrui – non intendeva, e non volle, sapere come. Accettai, ovviamente. Con Ronconi, non ci fu nessun altro accordo. Con lui ebbi qualche incontro, ma soltanto a proposito degli spazi in cui dovevano situarsi gli spettacoli e a proposito della Cooperativa d’appoggio (si scelse Teatroggi, di Bruno Cirino). Mai, tuttavia, volle conoscere, o io gli parlai, delle mie idee per la messa in scena, soprattutto dell’iniziativa Manganelli che andava maturando nella mia testa. La conobbe a “testo fatto”. L’idea di incaricare Manganelli per una “sua” versione dell’Otello nacque in primo luogo, in me, dal desiderio di evitare il rischio di farmi intrappolare nella struttura narrativa shekspiriana, nel cosiddetto “plot”, assai ingombrante e potente come in tutte le altre opere di Shakespeare. Volevo che Manganelli “distruggesse” una trama “popolare”, subito percebile dall’immaginario d’ogni tipo di pubblico. Facevo gran conto, perché la conoscevo, sulla sublime potenza musicale delle parole scritte di Manganelli, e io questo volevo: uno spartito verbale sul quale costruire immagini.
SCRISSE MANGANELLI PRESENTANDO LO SPETTACOLO:
A fine testo, consegnai a Luca il copione di Manganelli che avrei realizzato. Ronconi accettò senza fare una piega, non si oppose, non sollevò nessuna obiezione, e difese strenuamente la mia scelta (durante il periodo pre-realizzativo e realizzativo) contro un mare montante di critici sberleffatori e aspiranti censori (non parlo dei critici teatrali, che intervennero a spettacolo visto e non visto, ma di coloro che a vario titolo erano coinvolti nella progettualità Biennale – i “vigili” di Luca). Da qui è nato quel “Da Othello di William Shakespeare – Cassio governa a Cipro” che oggi spicca nella biografia di Manganelli. Ma il merito di aver proposto a lui questa avventura intellettuale mi è stato di fatto negato in molte sedi e continua ad esserlo ancora, con una pervicacia che mi spinge a pensare non a un errore o a un difetto di informazione, ma a un vero e proprio intento parapolitico, nutrito di premeditazione e di rancori inspiegabili, che ha al fondo l’obbiettivo di una cancellazione deliberata della memoria storica o di un travisamento interessato della realtà”.
Tra cancellazioni e assenze
Serra si riferisce in modo particolare a due documenti. In primo luogo a un trafiletto di Rodolfo di Giammarco su La Repubblica (19 aprile del 2003) in cui si dice: “( L’opera “Cassio governa a Cipro”) scritta da Giorgio Manganelli per Carmelo Bene che la usò per la radio…”. “Che Bene l’abbia usata, dice Serra, non c’è dubbio, ma il testo era quello pensato e redatto da Manganelli per me e non per Carmelo”. Serra scrisse a Corrado Augias, che tiene su La Repubblica la rubrica delle lettere, chiedendo una rettifica, ma non apparve mai né lettera, né rettifica ed apparvero invece, al loro posto, poche righe dello stesso Augias in calce ad una lettera in cui Elisabetta Pozzi sollevava il problema della scarsa informazione data dalla televisione al teatro, sotto il titolo “Se Amleto non appare più in tv”. Il curatore della rubrica, nella sua risposta, si chiedeva: “Se qualche volta, invece di mettere in scena sempre gli stessi “classici rivisitati” da qualche “geniale regista” il teatro provasse di nuovo a farsi “specchio alla realtà” come suggeriva il vecchio Amleto ?”. Augias di sicuro rispondeva polemicamente alla Pozzi, ma anche, non tanto metaforicamente, a Serra. E la data lo conferma: 26 aprile 2003, poco dopo aver ricevuto la lettera del regista.
Il secondo documento è invece recentissimo ed è una raccolta di scritti di Manganelli, dal titolo “Tragedie da leggere”, uscito per i tipi dell’editore Aragno (febbraio del 2005) a cura e con un’ampia prefazione di Luca Scarlini (6). Il volume contiene nove tragedie: “Teo”, “Monodialogo”, “Il funerale del padre”, “Perplessità celeste”, “In un luogo imprecisato”, “Hogh tea”, “Il personaggio” e appunto “Cassio governa a Cipro”. Nella prefazione alla raccolta degli scritti di Manganelli – che dovrebbe avere un seguito e comprendere anche lavori che, a quanto mi si dice, lo scrittore non avrebbe mai voluto veder pubblicati – Luca Scarlini ignora di fatto l’opportunità, se non la necessità, di intendere il rapporto Manganelli-Serra come centrale nell’operazione veneziana del “Cassio”.
Perlini e Serra rappresentano indubbiamente due casi diversi. Perlini, per l’ “Otello” veneziano, procede, secondo il suo solito, non da un testo, sia pure riscritto, ma da una sua personalissima invenzione, fatta da un lato di metafore sul tema e dall’altra da una sorta di allucinata fantasia capace di manipolare tutti gli elementi a sua disposizione per una messinscena allusiva di un testo, ma del tutto autonoma nella specificità del racconto. Scrive Bartolucci nel fascicolo veneziano di presentazione: “E’ necessario ogni volta lasciarsi afferrare dal viaggio perliniano per fantasmi, su un’irregolarità di fondo…”. I suoi lavori non portano altre firme che la sua, anche se può esservi un richiamo a testi di Pirandello o di Shakespeare. Ben diverso è quanto accade in casa Serra. Questi è un regista quasi sempre legato all’interpretazione di un testo, il più delle volte suo, cui dà una lettura in immagini, dialoghi, sequenze, movimenti di camera, luci. In teatro, e nel teatro manganelliano, tutto è parola e linguaggio e grazie alla regia diventa immagine, come interpretazione, usata per rendere le sottigliezze o gli artifici o le allusioni del dialogo e del monologo; strumento di racconto e produttrice di emozioni che passano dall’occhio alla coscienza. Leggere questo intreccio tra testo e immagine (in senso lato, fino alle scenografie e ai movimenti) e valutarlo nei suoi esiti è compito della critica
Ma questo non accadde nel ‘74 a Venezia e certamente il tipo di scelta che lo Scarlini fa oggi selezionando le critiche di allora, aggrava l’assenza di ogni valutazione di merito. Si può capire che la forza del nome di Manganelli, i rapporti amicali e di gruppo portassero la maggior parte dei critici a rivolgere tutta l’attenzione soprattutto, anzi quasi esclusivamente al testo. Si può capire che il nome di Serra, nonostante l’alta qualità della sua produzione televisiva e cinematografica, dicesse poco a chi, in quei tempi, considerava la tv un giocattolo senza cervello e senza anima per masse incapaci di intendere e di volere, ma rivolgere attenzione a quel rapporto sarebbe stato un impegno necessario per meglio capire quello che stava accadendo sul “palcoscenico” veneziano, senza che per questo qualcuno dovesse modificare il proprio legittimo giudizio di valore. La regia e la messinscena furono di fatto ignorate, o trattate con sbrigativa indifferenza, là dove queste avevano invece un ruolo che pesava quanto il testo stesso. Quello che accadeva sul palcoscenico aveva infatti aspetti molteplici e non soltanto artistici. Si ponevano in discussione i temi della revisione di culture e di stereotipi, di linguaggi e di archetipi, di ruoli, di autori e di regie, di pubblici e di palcoscenici e infine di politiche. Disquisire soltanto di un frammento di questo intreccio ricchissimo ed esplosivo non era modo intelligente di portare a conoscenza quello che si era chiamati a giudicare. Ma è ancor più grave, per chi ne scrive oggi, l’assenza di ogni contestualizzazione che priva il giudizio critico dei fervori e delle ragioni del tempo.
Sperimentare con l’elettronica
Ne parlo con Serra, riprendendo il filo della ricostruzione. Perché Ronconi si rivolse a te per proporre il terzo anello della catena delle arti, la televisione? “Per due motivi, ripete Serra, perché conosceva la mia disponibilità, anzi la mia voglia di sperimentare e perché conosceva i miei lavori. In tv c’erano allora almeno tre tendenze: una che cercava di immettere il cinema nei processi di produzione e di diffusione della tv; una che cercava commistioni tra cinema e televisione ed una infine, forse minoritaria, ma ostinata nella sua sperimentazione, che cercava soluzioni specificamente televisive, del tutto elettroniche. Io facevo parte sia della prima sia di questa terza corrente. Non ho mai escluso l’uso delle tecniche cinematografiche, al contrario: ma solo quando serviva alla sperimentazione, alla rottura delle convenzioni televisive. In casi come “La rete Jeanson” o “Il processo Cuocolo” le riprese in elettronica furono appunto videografate, cioè trasferite su pellicola, poi montate, a lungo, in moviola cinematografica, e così trasmesse, come “film” (primo esempio di sperimentazione di queste tecniche in televisione). Ma quando ho lavorato più tardi su testi come il “Che fare?” di Cernicewskij (del ’79) o “La signora Morli uno e due” di Pirandello (più di dieci anni dopo, nel ‘91), ho evitato ogni ripresa in esterni e l’uso di ogni mezzo cinematografico. Tutto fu registrato in elettronica e non è un caso che molto spesso, come nel “Che fare?”, abbia impiegato lunghissimi piani sequenza, ovviamente nemici di ogni montaggio in moviola, una tecnica cinematografica che in questo caso volevo evitare. La scelta che Ronconi fece di me nacque da tutto questo.”
Una scelta che premiava stile e rigore, ma, come vedremo, anche la fantasia.
Quali furono le fasi di costruzione dello spettacolo? Risponde Serra:“Uno dei consigli di Luca, proprio agli inizi dei nostri colloqui, fu, ribadisco, l’invito a liberarmi nella sperimentazione, un invito all’invenzione e alla fantasia. Pensai subito ad un mix tra tv ed altri mezzi: per esempio quello radiofonico. Costruire una sorta di “alter” rispetto al testo, con l’immissione di brani tratti dagli archivi della radio, che portassero in scena le voci di “Otelli” diversi. O anche la presenza di un attore che, seduto su un alto scranno, recitasse un suo testo, in asincronia con gli altri che agivano su quello base. Era la proposta di un “Otello” smembrato. Infine prevalse in me l’idea del “barco” (grande schermo), la più tecnologicamente attraente, anche se di difficile realizzazione, come i fatti dimostreranno in seguito. Con il grande schermo-video, puntavo a un oggetto tecnologico che era appena agli inizi e, ora lo si può riconoscere, mi spinsi troppo avanti. Ma la soluzione era suggestiva e mi piaceva perché frantumava e riaccorpava, in una sequenza fatta di segni e di incroci continui, linguaggi, situazioni, personaggi e realtà diversi.
“In questo quadro nacque anche l’idea di rivolgersi per la messinscena a Bruno Cirino e alla sua compagnia (8). Bruno lo avevo già scelto per il “Processo Cuocolo” (fu, in assoluto, il suo primo ruolo di protagonista), poi lo chiamai per “Dedicato a un medico” (9), un telefilm a puntate sulle malattie mentali, un vero “scandalo”, di cui la critica disse un gran bene, ma che dovette affrontare le censure di Ettore Bernabei prima e di Sergio Silva dopo. In Ronconi c’era un forte ricordo di queste mie esperienze e da qui nacque anche la proposta di chiamare Cirino e Teatroggi a Venezia”.
Se si immaginava la presenza, sul palcoscenico dell’“Otello”, di un grande schermo (oggi di uso comune, basta pensare ai congressi) era inevitabile che vi fossero delle telecamere per le riprese. Do ancora la parola a Gianni Serra: “Rivendico di essere stato il primo a usare telecamere e video per uno spettacolo teatrale. Era un’idea che riguardava la costruzione scenografica e le forme espressive dello spettacolo stesso”. Di lì a poco, sia i televisori che le telecamere furono utilizzati proprio da Ronconi, che diede ai monitor, collocati in scena, il compito di fornire immagini di “attori replicanti” o “anticipatori” di quello che si sarebbe visto e ascoltato. Il segno concreto dell’attore veniva così virtualmente dilatato, con effetti espressivi e suggestivi di grande impatto.
“Le cose, durante le prove, parvero funzionare perfettamente e cancellai le mie prime perplessità”, prosegue Serra. “L’altro elemento forte, nelle decisioni di Ronconi, fu quello di decentrare al massimo lo spettacolo(10). Di questo parleremo anche in seguito, perché l’iniziativa pesò molto nei rapporti tra una parte autorevole della critica e la Biennale. Mi riferisco adesso al solo spazio del Petrolchimico, ovvero a un ambiente enorme, rettangolare, della grande industria chimica che si trova a Porto Marghera, dove allestimmo la “prima” del “Cassio governa a Cipro”. La nostra idea di scenografia era questa: lo spazio che avevamo a disposizione nel Petrolchimico sarebbe stato diviso in due dal grande schermo. Il pubblico, entrando, lo avrebbe trovato davanti a sé. A quel punto poteva scegliere di restare lì, oppure di sfilare ai lati e passare dall’altra parte, dove era allestito un palcoscenico quadrato, centrale, intorno al quale, su pedane basse, si collocavano altri spazi più piccoli – satelliti, furono definiti – su cui si sarebbero svolte altre azioni sceniche. Intorno c’erano le sedie.
IL PALCOSCENICO CENTRALE
Ma il pubblico poteva anche girare intorno, per vedere gli spazi “invisibili”, opposti, quelli sulle pedane basse. In questo spazio/spazi complessivi avrebbero agito gli attori e lì sarebbero state collocate le telecamere destinate a riprendere e ritrasmettere sullo schermo lo svolgersi del lavoro e il comportamento del pubblico. Sullo schermo, infatti, collocato di faccia all’ingresso (agli inizi ci era stato assicurato che lo schermo era mobile e quindi il gioco sarebbe stato molto più complesso e ricco) dovevano apparire le immagini dei personaggi – dilatate in chiave drammatico-espressiva, non in chiave di documentazione o narrativa – frammentate da quelle dei volti della gente, dalle loro espressioni, dalle loro reazioni. Il pubblico avrebbe visto sullo schermo quello che oggettivamente non poteva vedere, svolgendosi l’azione anche negli spazi sulle pedane basse, e anche se stesso, in una documentazione di tipo giornalistico. Dunque gli spettatori potevano scegliere: o seguire lo spettacolo sullo schermo o seguirlo dal vivo. Oppure alternare entrambe le cose. Tutto era in diretta, non c’era alcuna registrazione”.
“Questo fu il progetto”, continua Serra. “Purtroppo le cose non andarono esattamente come avevamo previsto e in particolare come volevo io. La tecnologia era ben diversa da quella che si potrebbe usare oggi e venne meno, almeno in parte, alle nostre aspettative: la fantasia aveva travalicato, insomma, i limiti del possibile. Una fantasia, sia chiaro, non astratta, perché i risultati ci erano stati garantiti con precisi impegni che non furono però mantenuti. Da parte sua, l’organizzatore dello spettacolo, legato al gruppo di Cirino, tirò sempre a risparmiare su tutto, anche sulla qualità degli strumenti elettronici che in quella situazione erano fondamentali. L’apparato tecnologico funzionò dunque con difficoltà al Petrolchimico, funzionò con risultati scarsamente apprezzabili, da un punto di vista tecnico, ma evidenti. Per i due spazi successivi, quello dei Cantieri Navali alla Giudecca e quello del Teatro Tenda di Mestre, avevamo previsto un adattamento particolare, funzionale alle forme e alle dimensioni dei luoghi, ma dovemmo praticamente abbandonare ogni ipotesi d’intervento televisivo”.
Un grande sforzo che fu di fatto ignorato allora e che viene ignorato ancor oggi. E’ vero che quel progetto scenico, in tutta la sua interezza e con i limiti ora detti, trovò sbocco soltanto al Petrolchimico, ma è altrettanto vero che proprio al Petrolchimico intervenne la critica a giudicare.
Le stesse pubblicazioni della Biennale, là dove riportano le cronache dell’evento attraverso la rassegna della stampa, la selezione dei dibattiti e degli incontri, ignorano di fatto quell’aspetto. Ci sono soltanto, a pag. 381 dell’Annuario (vedi bibliografia, n.d.r.) un paio di fotografie dello spettacolo che rendono giustizia allo sforzo inventivo e documentano l’uso della strumentazione tecnologica. Ma tutto questo, anche nelle sue insufficienze e contraddizioni, conferma l’eccezionalità di quello spettacolo: eccezione alla normalità del teatro borghese, innanzitutto, ma anche, per dimensioni e caratteri della proposta, eccezione rispetto agli altri esperimenti.
Che cosa capiscono gli operai ?
“Cassio governa a Cipro” fu uno spettacolo decentrato, ovvero collocato fuori da un qualsiasi spazio non solo deputato alla rappresentazione teatrale, ma persino utilizzato per qualsiasi altro genere di rappresentazione o di fiction. Si trattava, per la “prima”, dell’ambiente di una fabbrica in piena funzione, il Petrolchimico, con un pubblico prevalentemente operaio, lì invitato dal Comitato di fabbrica e dal gruppo che si occupava dei corsi delle 150 ore (11), dunque all’interno di contesti sociali ben precisi che svolgevano funzioni particolari nel quadro del “diritto alla cultura” da parte di tutti.
Una cultura difficile, nel caso specifico, a partire dal testo manganelliano dell’“Otello”, che si innestava in una scommessa civile e politica di tutta la Biennale. Aspetti e problemi di un rapporto e di un intreccio che la critica trattò colpevolmente allora per dettagli e frammenti e che gli storici di oggi trattano, ancor più colpevolmente, secondo lo stesso schema. Per i critici fu come se fossero stati costretti, in una notte buia e tempestosa, ad andare a recensire uno spettacolo in cartellone alla Fenice non alla Fenice stessa, ma, per l’idea balzana di qualcuno, in un posto fuori mano, scomodo e puzzolente, chiamato Petrolchimico di Marghera. Cosa che fecero da bravi e onesti professionisti quali erano, raccontando poi, negli articoli, la loro esperienza di vita in quella notte dannata, e dando il loro giudizio come avrebbero potuto darlo per un’edizione strampalata di un Goldoni, di un Pirandello o di un Fabbri alla Fenice.
Tuttavia le recensioni toccarono anche la questione del rapporto tra operai e cultura “alta”, si direbbe oggi, e del trasferimento di un’opera classica dalla sua sede “naturale”, la Fenice, o il Malibran, a una fabbrica. Temi che sembravano portare acqua al loro mulino. Una rapida antologia lo mostra con chiarezza. Lodovico Mamprin sul Popolo (organo della Dc) si domanda: “…era lo spettacolo più adatto per rompere il ghiaccio tra teatro e mondo operaio ?”. Incalza De Monticelli sul Corriere della Sera: “ Mi pareva che a tutta quella gente d’una variazione filosofico–morale sull’”Otello” non dovesse importare nulla (…) Altre…sono le operazioni teatrali da ambientare in una fabbrica”. “Di questa ipotesi (nanganelliana) non so quanto arrivi allo spettatore non professionale…” aggiunge Sergio Cabassi del Resto del Carlino. Cibotto, del Gazzettino e del Giornale d’Italia, attacca ancora la soluzione Petrolchimico-Manganelli scrivendo: “Insomma questa faccenda, alla quale Fenice, Biennale ed altri organismi ogni tanto ricorrono, in vena di coperture sociali, sa molto di retorica. Meglio portare gli operai alla Fenice, al Malibran, luoghi deputati…”. Ma anche a sinistra l’operazione non piacque del tutto. Elio Pagliarani, su Paese Sera, scrive: “ Conoscendo abbastanza bene…il lavoro di Manganelli, supponevo scarsamente adatta non che a maestranze petrolchimiche, anche a tecnici e magari ingegneri di Marghera l’opera sua. E sono stato facile profeta.” “Profeta di che?”, interviene polemicamente Serra, “Profeta di un pubblico smarrito? Di mormorii d’incomprensione e d’insofferenza operaia? Delle nominate maestranze petrolchimiche che protestavano contro una roba incomprensibile? Pagliarani e gli altri non si sono dunque accorti che gli operai si divertivano e molto, e applaudivano a scena aperta, e stipavano ogni spazio non lasciando un centimetro vuoto? E che alla fine hanno accolto Manganelli con un’ovazione? Erano forse addestrati e pagati dalla Cgil, come direbbe oggi Berlusconi?”. Ma questo a dopo. Anche Arturo Lazzari dell’Unità si chiede: “Il discorso che essa fa (la raffinata e ristretta lettura del testo) non è un discorso popolare né, tantomeno, politico: perché dunque averlo portato nel capannone del Petrolchimico a Mestre ?”. Per non dire di Ludovico Zorzi che torna sul Corriere della Sera con un duro attacco: “ Un Othello sofisticato alla Petrolchimica, cioè nell’inferno di Portomarghera, è un atto di leggerezza politica da non ripetere, che accentua il muro di diffidenza tra intellettuali e classe operaia”. Ed è abbastanza singolare che debba essere proprio il liberale Mondo, per la firma di Guido Fink, a rispondere a questi attacchi scrivendo : “Si può sorridere quando Bruno Cirino, smessi i panni di Jago, dopo la letterata e sofisticatissima rielaborazione dell’“Otello”, a cura di Giorgio Manganelli, apre il dibattito (12) rivolgendosi ai rappresentanti delle “organizzazioni democratiche di base” eventualmente presenti negli ex cantieri navali della Giudecca: ma il bello è che sindacalisti e operai della Giudecca ci sono davvero”.
Eppure tutte le annotazioni dei critici che abbiamo qui riportato (ed altre ve ne sarebbero), sollevano un problema, né irrilevante né nuovo, quello del “popolare in arte”, ovvero nella letteratura, nel teatro, nella pittura, nel cinema e altrove. Ma nessuno di quei critici lo affronta direttamente (sia pur nei limiti imposti da una recensione) anche se è, obbiettivamente, uno dei temi centrali, un tema che corre nelle pieghe di tutti i movimenti, dal sessantotto in poi, che leggono e reinterpretano in mille modi diversi le pagine di Gramsci, ovvero dello studioso più citato in merito a quella questione. Mentre è sempre più presente nella vita sociale e culturale del paese il fenomeno della tv, che finirà per annullare o spedire nelle nuvole il dibattito stesso, fissando i canoni del popolare al più basso dei livelli, quello statistico, o procedendo ad una comoda divisione tra cultura “alta” e cultura “bassa”.
Sul tema del popolare, e con esso della televisione, scrive lo stesso Manganelli, che di fatto risponde a tutti con un breve articolo sull’Espresso, dal quale ritagliamo queste righe:. “Shakespeare è estremamente complesso e difficile, scrive Manganelli, anche sul piano linguistico; i suoi testi brulicano di metafore, di giochi verbali, di invenzioni linguistiche di ogni sorta; e tuttavia Shakespeare fu scrittore teatrale estremamente popolare, di successo (…). Ora, se il difficile Shakespeare era popolare ai suoi tempi, bisogna pensare che gli spettatori, i plebei elisabettiani, fossero tutti geni; e se noi il linguaggio difficile non lo capiamo più, se non con un certo allenamento, vorrà dire che siamo diventati bischeri. Io penso che le cose non stiano a questo modo; ho l’impressione che quel linguaggio sia diventato da difficile incomprensibile semplicemente perché è cambiato il nostro atteggiamento verso il linguaggio, verso l’uso che se ne può fare. Questo cambiamento è avvenuto da un secolo, forse anche meno, Grazie a giornali, radio, televisione, oggi la nostra società parla il linguaggio più misero, affranto, falso, ripetitivo, morto, neghittoso che si sia mai parlato (…),. Il linguaggio di Shakespeare non è né colto né intellettuale: è semplicemente totale”.
Ad affrontare gli stessi temi, ma in un’ottica ovviamente diversa, sono i diretti interessati e cioè gli operai del Petrolchimico. Infatti, dopo le rappresentazioni dell’ “Otello” in fabbrica – che vide una partecipazione larga ed entusiasta di lavoratori – furono organizzati, come abbiamo detto, dibattiti e altrettanto fu fatto in occasione delle rappresentazioni alla Giudecca e a Mestre, a loro volta premiate da un’affluenza straordinaria di un pubblico divertito e plaudente. Una serie di interviste fu poi condotta tra i membri dell’esecutivo del Comitato di fabbrica che in qualche modo aveva partecipato all’organizzazione dell’iniziativa e l’aveva sostenuta. Numerosi furono gli interventi, in ciascuna situazione, stimolati dalle domande poste da Gianni Serra e soprattutto da Bruno Cirino. Si tratta certamente di esperienze proprie a un determinato periodo che combina varie aspirazioni e volontà, quelle dei lavoratori a partecipare a processi culturali dai quali erano sempre stati esclusi e quelle degli intellettuali impegnati a stabilire un rapporto nuovo con le masse popolari che stanno progressivamente entrando nel grande mercato della cultura.
Le risposte operaie mettono in luce alcuni punti chiave di discussione: il rapporto tra l’“Otello” manganelliano (testo e messinscena) e le sue funzioni verso la condizione sociale dei lavoratori (lo sfruttamento in fabbrica); il problema della comprensibilità del testo e della sua larga fruibilità, l’interesse oggettivo per lo spettacolo in sé; il desiderio o meno di partecipare alle serate, ecc. Le domande e le risposte sono state raccolte e ordinate in un prezioso fascicolo (vedi nota 12 e bibliografia) ma è pur vero che rappresentano sempre una selezione, non valida neppure sul piano statistico. Una cosa è però certa: gran parte di quegli operai che partecipano ai dibattiti o che sono stati intervistati riconosce validità all’iniziativa generale (decentramento e teatro in fabbrica) e a quella particolare dell’“Otello” di Manganelli-Serra; dichiarano di essersi vivamente interessati e alcuni fanno un’osservazione acuta: nonostante le difficoltà, lo spettacolo nel suo complesso, gli attori, i costumi, i movimenti di scena, l’originalità dell’allestimento hanno rappresentato una rottura positiva, hanno affascinato e conquistato. D’altra parte che vi fosse un gran pubblico a tutte le rappresentazioni – sia pure diversificato, sostiene oggi Gianni Serra, operaio quello del Petrolchimico, misto quello della Giudecca, più intellettuale e acculturato (molti studenti, ad esempio) quello del Teatro Tenda di Mestre – e che questo pubblico abbia applaudito con convinzione, imprimendo sullo spettacolo il sigillo del successo, è stato riconosciuto da tutti i cronisti, anche dai più malevoli verso l’oggetto del loro interessamento. Vi è dunque una contraddizione tra atteggiamento diffuso dei critici e realtà, una contraddizione probabilmente fondata su un pregiudizio o sull’inconscio desiderio di conservare un patrimonio di casta (o di classe), evitando così una rappresentazione oggettiva e cronachistica del vero. E vi è l’assenza, vorrei aggiungere, di curiosità professionale, che avrebbe dovuto spingere a cercar di capire il comportamento operaio o del pubblico in genere, senza sovrapporre a questo le proprie idee e posizioni. Ma se i travagli del tempo possono aver portato gran parte di quei giornalisti a ignorare tutta una serie di domande e di problemi, questo è pressoché imperdonabile in chi, nei tempi nostri, si pone a rileggere i pezzi di quel mosaico in chiave di critica storica o anche semplicemente di cronaca storica.
La prima serata del Petrolchimico vide Manganelli prendere la parola, ma resta il ruolo politico svolto da Cirino. “Bruno, racconta Serra, andava a fare i dibattiti anche nei quartieri, nei mercatini veneziani ed erano soprattutto dibattiti politici. Lui era particolarmente impegnato, la sua compagnia aveva portato a Roma e per l’Italia testi politici, a partire da quelli del tedesco Toller e lui stesso era sensibile al rapporto concreto con i lavoratori. Ma Bruno, in realtà, restò sempre perplesso a proposito dell’“Otello” di Manganelli. Avrebbe francamente preferito quello originale, di Shakespeare”.
Parola, testo e belle donne
Serra affronta anche il tema della rappresentazione scespiriana in sè. “La caratteristica della maggior parte delle opere di Shakespeare, dice, è racchiusa tutta nella possibilità di una lettura a livelli diversi. C’è un plot, una trama che spesso può essere definita una storia da fumetto, una “storiaccia”, ma da qui si parte per una costruzione poetica. Noi, nell’“Otello” della Biennale, escludemmo fin dall’inizio la possibilità di raccontare secondo la trama tradizionale ed optammo per una destrutturazione del plot e dei caratteri, in particolare di quello di Jago. Manganelli fece, sulle e con le parole, una straordinaria operazione che per certi versi era un’operazione parallela a quella fatta da Memè Perlini, sia pure con altre intenzioni e risultati. Perlini, a Venezia, si liberò totalmente dalle parole del testo, ridotto a dieci battute, a favore di una invenzione di immagine che con l’ “Othello”, quello con la h, non ha niente a che vedere. Manganelli non inseguì il plot, ma giocò sugli elementi della trama per costruire un discorso tutto suo ed è questo che abbiamo messo in scena. Non si dimentichi che da noi il Moro non aveva la faccia nera; che il famoso fazzoletto si era moltiplicato in dieci esemplari che correvano velocemente di mano in mano; che c’erano due Jago, un’invenzione, questa, nata da Manganelli, per aiutare un disagio di memoria espresso da Cirino. Il personaggio di Jago, da lui interpretato, fu diviso in due, per cui in scena apparvero un Jago donna (Nicoletta Rizzi – la narrazione) …
… e un Jago uomo (Bruno Cirino – il commento)
… soluzione il cui risultato scenico interpretativo convinse Manganelli e il pubblico, anche se poi fu uno dei punti su cui la critica, ovviamente, rivolse la propria attenzione (senza troppo esprimersi, “scuotendo la testa”.
Credo però che proprio l’assenza della trama, di riferimenti ortodossi e tradizionali abbia innervosito alcuni dei nostri recensori. Corrado Augias scrisse che quello era uno spettacolo per chi conosceva bene l’“Otello”, perché chi non lo conosceva non poteva capire niente (ovvero non avrebbe capito niente della trama originale). In realtà non si trattava di recuperare il plot tradizionale attraverso Manganelli, ma di leggere il testo di questi come testo autonomo, indipendentemente da quello scespiriano. Così fece il pubblico e molto si divertì. Per il testo, certamente, ma anche per il gioco costruito dagli attori, per le scene, per i costumi e, perché no ?, anche per le belle ragazze, alcune a seno nudo, che erano sul palcoscenico. Esiste un piacere visivo, “tattile”, esiste il gusto per una sorta di festa pagana (un po’ la stessa cosa che aveva decretato il grande successo dell’“Orlando” di Ronconi). Anche il fatto di recitare nel Petrolchimico o alla Giudecca o sotto il tendone di un circo, erano fattori di novità ed era una novità che piaceva, attraeva”.
Qualche anno più tardi, in una edizione libresca a grande diffusione del dramma di Shakespeare (vedi bibliografia) fu riportato il commento di un anglista di grande nome come Agostino Lombardo, a proposito dell’ “Otello”. E’ un commento illuminante sul testo scespiriano, che apre oggi le porte a una comprensione maggiore del discorso di Manganelli. “Ancor più che in quelle opere (“Macbeth”, “Re Lear”), scriveva Lombardo, tale rappresentazione (del male del mondo) muove da una centralità del problema del linguaggio che era già in “Amleto”. In effetti, proprio grazie alla terribile lucidità e violenza con cui il problema della parola si configura in “Amleto”, si perviene, con l’“Otello”, a quella che si può veramente definire la messa in scena della tragedia della parola”. E più avanti, sempre a proposito di Otello: “Allo stravolgimento morale che segue alla nascita, in lui, della gelosia (una gelosia “inventata” dalle parole di Jago…) corrisponde uno stravolgimento linguistico; le parole si imbarbariscono, si imbestiano; la melodiosa sonorità dei primi discorsi si frantuma, si fa ritmo spezzato, ansimante”. Che cosa ha fatto Manganelli se non partire da questa centralità della parola e su di essa giocare tutta la costruzione del personaggio e della scena, plasmando in essa e intorno ad essa la personalità di Jago ?
Giunti alla fine dell’intervista, torniamo alle note di cronaca e, se volete, alle polemiche. Gianni Serra ha sempre avuto un rapporto difficile con la critica: non tanto con quella televisiva che in genere ha sempre detto un gran bene di lui, ma con quella cinematografica (si ricordi il caso di “La ragazza di Via Mille Lire”, che sempre a Venezia e sempre alla Biennale, sia pure del cinema, portò a un vero e proprio scontro e a reciproci insulti tra un gran numero di critici e il regista). “No, dice oggi Serra, non ce l’avevo e non ce l’ho ovviamente con la categoria dei critici, che immagino abbia gli stessi difetti di quella dei registi e di altri, ed è anche vero che le reazioni all’“Otello” non furono tutte uguali. Allora ero abbonato all’Eco della Stampa e trovai un gran numero di ritagli che parlavano molto bene dello spettacolo. I grandi giornali italiani, però, ebbero quell’atteggiamento di preconcetta ostilità che abbiamo già descritto. A differenza, si badi bene, dei critici stranieri presenti alla manifestazione. Ad esempio, mi riferisco alle recensioni del Finantial Times di Londra e a quella del The Daily American”.
Vediamo allora questa critica dell’inglese R.A. Youngche, che forse più di altri aveva a cuore il buon nome del suo connazionale Shakespeare. Lui parla con entusiasmo delle due versioni dell’“Otello”, quella di Perlini e quella di Serra, ma per quest’ultima ha una felice intuizione. Scrive: “Un’altra compagnia romana, la cooperativa Teatroggi, per la regia di Gianni Serra, apporta un vero tocco della Commedia dell’arte”. E in chiusura insiste: “Un finale sorprendente, ma verace della Commedia dell’Arte” e descrive questo finale (la festa pagana di cui parla Serra?) in cui tutti i protagonisti, quelli del palcoscenico centrale e quelli dei palcoscenici-satelliti vengono “assolti”, con Cassio che resta a governare Cipro insieme a Bianca, con Desdemona e Otello che ritornano a Venezia e con uno Jago che conserva la sua Emilia. Insomma, un capovolgimento della tragedia in commedia, un lieto fine generalizzato, lo stesso che nei secoli ha segnato momenti interi del teatro.
“Un giudizio acuto ed equilibrato, quello del Finantial Times, dice Serra, a differenza di quelli dei nostri critici maggiori. Questi, in realtà, erano contro l’esperimento di Ronconi e in particolare contro il decentramento e vennero soltanto alla “prima”, secondo ciò che vuole la convenzione, cioè allo spettacolo che presentammo al Petrolchimico. Furono anche traumatizzati da fatti esterni, da quella notte di tempesta che dovettero affrontare, nel buio e nel freddo, per arrivare alla fabbrica, spesso perdendosi nella nebbia. Non c’è una critica che non contenga un riferimento meteorologico. E’ evidente che una comoda poltrona alla Fenice sarebbe stata una soluzione migliore e più gradita e la calda sala di quel teatro il giusto luogo per ospitare intellettuali raffinati, in mezzo a un pubblico “bene”. Altro che il fabbricone del Petrolchimico!
Tra i critici, inoltre, esisteva uno schieramento trasversale, di cui gli eredi del Gruppo’63 (a parte Manganelli e pochi altri) rappresentavano una fetta importante. Era uno schieramento con posizioni anticomuniste che emergevano con forza. Basti pensare che si dava del comunista a Ronconi, così come si accusavano dello stesso “reato” Moravia e Pasolini, e anche la Biennale Teatro tout court finiva nello stesso calderone. Non sto parlando di un’avversione soltanto politica, e d’altra parte la quasi totalità dell’ex Gruppo‘63 era ben lontano da posizioni di destra o fasciste e molti di loro si dichiaravano di sinistra, ma di un’avversione culturale che partiva da quella premessa e da quel pregiudizio. In quei giorni Alberto Arbasino fece clamore affermando che il lavoro di Manganelli portato agli operai di Marghera era paragonabile alla famosa brioche che Maria Antonietta voleva dare agli insorti di Parigi che chiedevano pane. Una battuta che Manganelli non dimenticò mai e di cui scrisse ironicamente più volte. L’attacco a Ronconi, l’avversione politica alla sua iniziativa di decentramento, si trasferì alla fine sul nostro spettacolo. Con Perlini la situazione era stata diversa. Il suo “Otello” era stato allestito in Venezia, in una chiesa sconsacrata, un luogo tradizionalmente deputato ad accogliere spettacoli teatrali, e soprattutto“non scomodo” ”.
Personalmente ritengo anch’io che non si trattasse soltanto di un pregiudizio politico anticomunista – si pensi a Pagliarani che lavorava e scriveva per Paese Sera e che, con i comunisti, ovvero con intellettuali militanti nelle file del Pci, collaborava ogni giorno. Ritengo piuttosto che vi fosse un’opinione culturale che fu di molti, anche di autorevoli esponenti politici e di settori dello stesso Pci, che nasceva dalla convinzione che alla domanda di cultura delle masse operaie non si dovesse rispondere con atti solo in apparenza democratici e rivoluzionari, ma nella sostanza demagogici , come il decentramento o, per essere più chiari, come il teatro in fabbrica. Una posizione che oggi potremmo definire di “destra”, senza riferimento agli schieramenti politici, mentre a “sinistra” se ne collocava un’altra, fondata sull’idea che agli operai, in fabbrica o altrove (sala-teatro tradizionale, teatro-cantina, strada, palcoscenico della Festa dell’Unità, ecc.) si dovesse portare la cultura o il teatro di “classe”, dai tedeschi Toller a Brecht, ad esempio, ad americani come Odets o a sovietici come Majakovskij e a quegli italiani che scrivevano testi di teatro politico o di cronaca sociale (la Maraini, tanto per fare un nome). Nel dopoguerra il Pci si era mosso su questa linea elaborando un vero e proprio stile, formatosi intorno al cosiddetto “teatro di massa” che dominò le Feste dell’Unità, e non solo. Un fenomeno di grande interesse, un teatro di agitazione e propaganda, completamente dimenticato oggi nei suoi testi e nelle sue rappresentazioni, e che non fu neppure un’invenzione del tutto originale, perché riportava alla memoria quello fascista “delle masse”, quello sovietico dello stesso tipo e, continuando ad andare a ritroso, ricordava persino fenomeni registratisi durante le rivoluzioni francesi, da quella comunarda a quella giacobina, per poi perdersi nella notte dei tempi (si pensi alla Sacra rappresentazione del Medioevo). Dico tutto questo per segnalare la complessità di un problema che emerse, forse un po’rozzamente, in anni (i 60 e i 70) in cui sembravano riaprirsi le dighe della storia a riversare in pianura le tumultuose acque delle umane vicende e degli umani pensieri, con il riemergere di tutte le opzioni sociali, di tutte le spinte e controspinte tra progresso e reazione nello stesso, variegato e ricchissimo mondo della cultura. Anche Gianni Serra ne subì in qualche modo le conseguenze, quando la sezione veneziana de il manifesto lo criticò duramente per aver accettato di partecipare alla Biennale di Ronconi, considerata “compromissoria”. Nell’occasione vi fu un intervento politico di Rossana Rossanda in suo favore.
Serra, alla fine della nostra chiacchierata, è però del tutto tranchant: “Il pregiudizio politico anticomunista comunque c’era e lo spettacolo fu visto attraverso quel filtro. Si attaccò così la sperimentazione di Ronconi (e la nostra), di quello stesso Ronconi di cui, poco tempo prima, si era detto un gran bene a proposito dell’“Orlando Furioso”, che di sperimentazione ne conteneva moltissima. Ma lì non giocò a favore del regista soltanto il successo di pubblico, ma il fatto che quel pregiudizio politico ancora non c’era. Un pregiudizio che invece ci fu a Venezia e continua ad esserci ancora. Forse perché in quegli anni le forze progressiste, politiche, sociali e culturali, persero la grande battaglia che i giovani avevano avviato nei ‘60. Da questa ipotesi discende allora una domanda: chi sono gli Scarlini, la figlia di Manganelli, la Papetti, che dello scrittore fu compagna, che oggi collaborano a il manifesto, organizzano convegni e scrivono libri? Chi sono? i vincitori che riscrivono la storia? Per cui, a più di trent’anni di distanza, hanno il diritto a nascondere la verità, a scrivere senza ascoltare le fonti principali, a fare un convegno su Manganelli, in cui si parla di “Cassio governa a Cipro”, non invitando ufficialmente chi prese l’iniziativa di chiamare Manganelli a Venezia e che lavorò con lui per mesi? Ma ci sono cose che si intrecciano, attraverso il tempo: nel 1977, quando Manganelli pubblicò per Rizzoli il “Cassio”, Angelo Guglielmi lo sconsigliò dall’inserire il mio nome nella prefazione, in quanto io ero stato “molto criticato” e di conseguenza il citarmi sarebbe stato “dannoso per lui”. L’episodio me lo raccontò l’amico Manganelli e io ho sempre creduto a quella informazione che testimonia un “qualcosa” che continua a provocare i suoi effetti perversi attraverso gli anni, anzi, i decenni. C’erano state davvero tante critiche negative da determinare reazioni di tal genere? Delle critiche abbiamo parlato abbondantemente, ma ci fu anche un successo – di questo abbiamo detto, ma è opportuno ripeterlo – che fu la risposta più chiara all’opera di Manganelli e a quella mia. Io, regista soprattutto di televisione, non ho mai avuto un successo di pubblico così grande e visibile, a parte quello che anni dopo ottenni con il film “La ragazza di Via Millelire” che restò per mesi in testa alle classifiche del nord. Ma al nord, perché nel centrosud il film non fu mai distribuito”.
Ringrazio Serra per la sua lunga intervista su un tempo e su avvenimenti fin troppo dimenticati. forse per indifferenza, forse per ignoranza, forse per deliberata scelta politica.
__________________________________________
1. Gianni Serra, regista televisivo e cinematografico. Fino al 1974 ha diretto: “Un caso apparentemente facile”, film di coproduzione Luce-Rai per la serie Rai Storie italiane, 1968; “Il processo Cuocolo”, serie Rai Teatro inchiesta, n.22, 1969; “La rete”, serie Rai Teatro inchiesta n.24, 1970; “Progetto Norimberga”, serie Rai Teatro inchiesta n.29, 1971; “Uno dei tre”, film di coproduzione Cct-Rai (minoritaria), distribuzione Dae, 1972, “Dedicato a un medico”, film Rai, 1973; “Fortezze vuote”, film prodotto dal’Unitelefilm, distribuzione Arci-Uisp,1975 – nel 1980 ha diretto “La ragazza di Via Mille lire”, film di coproduzione Rai e Comune di Torino, presentato al Festival di Venezia ‘80 con esiti contrastanti e polemiche vivacissime.
2. Luca Ronconi regista teatrale. Inizia la sua attività come attore, nel 1963 compie le sue prime esperienze registiche che prosegue con una serie di compagnie. La critica lo scopre come uno degli esponenti dell’avanguardia italiana nel 1966 quando svolge la sua prima regia di libero impegno con “I lunatici” di Midelton e Rowley. Nel 1969 la sua notorietà e il suo stile sono consacrati da un successo internazionale, “L’Orlando furioso” di Ludovico Ariosto nella riduzione di Edoardo Sanguineti. Nel 1974 è nominato direttore della sezione Teatro della Biennale di Venezia (lo resterà fino al 1977).
3. Il Gruppo ’63 si costituì a Palermo in quell’anno e, come è stato scritto, “rappresentò in letteratura il fenomeno più fecondo dell’Italia del miracolo economico”. Ne fecero parte, tra gli altri, Nanni Balestrini, Alfredo Giuliani, Francesco Leonetti, Walter Pedullà, Edoardo Sanguineti, Giuliano Scabia, Luciano Anceschi, Renato Barilli, Gillo Dorfles, Umberto Eco, Angelo Guglielmi, Alberto Arbasino, Furio Colombo, Franco Lucentini, Luigi Malerba, Giorgio Manganelli, Giuseppe Pontiggia, Inge Feltrinelli e Vittorio Gregotti.
4. In una intervista a Mondo Operaio del novembre del 1974 il Presidente della Biennale Carlo Ripa di Meana dice tra l’altro: “Solo i liberali veneziani, tetragoni, dicono che il Pci è egemone; certo, i comunisti hanno collaborato e lavorato con grande impegno, ma la “cifra” della Biennale non rispecchia per modi, per temi e per articolazione, la politica culturale del Pci. Né d’altra parte vi è mai stata da parte comunista una pretesa di questo genere, anzi il contrario”. Riportata in Annuario del 1975-Eventi del 1974, pag. 556. Vedi bibliografia.
5. Il Gruppo “La maschera” era composto da Ines Beinhauer, Ann Collin, Crystel Dane, Mario Esposito, Curtis Gjonz, Nerina Montagnani, Renzo Rinaldi, Patrizia Sacchi, Enzo Turrin, Nora Vivian. Per lo spettacolo di Venezia le musiche furono di Alvin Curran; le scene e i costumi di Antonello Aglioti. Direttore di scena fu Giuseppe Ghigi.
6. Luca Scarlini insegna Tecniche narrative alla Scuola Holden e si occupa di drammaturgia contemporanea e di letteratura. Ha scritto numerosi saggi e tiene un blog su Internet.
7. Uno degli estensori dell’Annuario veneziano del ’74 così scrive di questo lavoro: “Dal testo di Shakespeare, dramma della gelosia di Otello, Manganelli ha tratto il secondo titolo dell’opera teatrale: “Cassio governa a Cipro”, puntando sull’autoanalisi problematica dell’animo di Jago, malvagio classico e gratuito, cui la versione tradizionale, troppo semplicistica, fa torto o lascia zone oscure. Da fattaccio di cronaca nera della società veneziana, la tragedia diventa quella di un uomo al centro di una trama ordita da lui stesso, di cui ignora le cause e che non riesce più a manovrare. Uno Jago “amletico”, nel quale i sintomi del delirio diventano strumenti e complici del delitto”. Scriveva lo stesso Manganelli: “Grazie alla centralità drammatica, psicologica e morale di Jago, la storia privata, il fatto di cronaca nera si scioglie, trasforma in materia di immagine, un puro problema di intelligenza insieme maligna e illuminante, sordida e illuminatrice”.
8. La Cooperativa Teatroggi, nella rappresentazione dell’”Otello governa a Cipro”, era così composta: Bruno Cirino, Roberto Della Casa, Annalisa Fierro, Atonia Forlani, Mauro Francescani, Alessandro Haber, Micaela Pignatelli, Paolo Malco, Antonio Meschini, Mario Rigetti, Nicoletta Rizzi, Renzo Rossi, Caterina Bandarin, Armando Fiabane, Luisa Pisolato, Susanna Vascon. Scene e costumi furono ideati e creati da Tomaso Sherman e Gioia Benelli che furono anche registi-assistenti ; consulente musicale fu Carlo Dansi; i movimenti mimici furono di Roberto Della Casa; assistente alle scene e ai costumi fu Stefania Benelli; direttore di scena Pino Di Giovanni; i costumi della Sartoria Tirelli; le calzature della Ditta Pompei; le parrucche della Ditta Rocchetti; le attrezzerie della Ditta Rancati; le apparecchiature televisive della Philips; la ripresa televisiva di Claudio Speranza. Cameraman fu Piergiorgio Albertini; tecnico eidophor fu Alfredo Varani; la collaborazione tecnica per i mezzi audiovisivi fu dell’Unitelefilm e l’organizzazione di Sebastiano Calabrò.
9 “Dedicato a un medico” film Rai-Tv del 1974, fa seguito, in una serie idealmente collegabile, a “Dedicato a un bambino” di Gianni Bongioanni (1971) e a “Diario di un maestro” (1973) di Vittorio De Seta, tutti interpretati da Bruno Cirino.
10. Il decentramento è un’idea che ha accompagnato sempre Luca Ronconi. In molte città lo realizzò per l’“Orlando Furioso”, poi vennero la Biennale di Venezia, il Lingotto della Fiat – sia pure dismesso, ma con tanto di treno in movimento- e infine, in questo 2006, a Torino, con il progetto “Domani”, pensato nell’ambito delle Olimpiadi invernali da Walter Le Moli che, per un caso del destino, è direttore di Teatrooggi (lo stesso nome della compagnia di Cirino). In questa occasione Ronconi ha utilizzato a Torino le dismesse fonderie di Moncalieri, la vecchia città del cinema Lumiq, un cinema di periferia, l’Astra, e il terzo piano di un grande magazzino che un tempo era un teatro e oggi torna ad esserlo, il Vittoria. .
11. Le “150 ore” fu una conquista dei lavoratori negli anni a cui ci riferiamo. Si tratta del diritto a 150 ore retribuite, in tre anni, per corsi o lezioni di cultura generale, qualificazione professionale, partecipazione ad iniziative culturali, ecc. Diritto oggi previsto e variamente regolato in tutti i grandi contratti di lavoro. Il gruppo collegato alla Biennale, quando si presentò il caso “Otello”, aveva già formulato i propri piani e non si mostrò del tutto disponibile a variazioni di tema. Infatti conservò la vecchia impostazione di lavoro, pur allargandola e inserendo nel proprio progetto il Teatro decentrato della Biennale.
12. Seguendo un andazzo del tempo, quasi tutti gli spettacoli furono seguiti da un dibattito tra gli attori, il regista Serra e il pubblico. In chiusura della prima serata parlò Manganelli, ringraziando gli spettatori. Per il resto i dibattiti ebbero il seguente calendario: al Petrolchimico, 5 novembre con Serra e Cirino; 6 novembre con Serra e Cirino; 7-8 novembre dibattiti ai cantieri navali della Giudecca; 9 novembre dibattito a Mestre. Seguirono interviste all’esecutivo del Consiglio di fabbrica della Montedison e furono raccolti documenti sull’“Otello”dei lavoratori che fruivano delle 150 ore. Ampi stralci dei dibattiti, delle interviste e dei documenti si trovano raccolti in AA.VV. Fabbrica quartiere teatro: Otello a Marghera, citato in bibliografia.
MAURIZIO MASSABO’
Bibliografia essenziale AA.VV. Cantiere Manganelli, fotobiografia, la vita, le opere. A cura del Comune di Roma, Assessorato alle politiche culturali, Casa delle Letterature, Roma, 2002
AA.VV. Da Othello di William Shakespeare, Cassio governa a Cipro di Giorgio Manganelli, fascicolo/programma di sala per l’Otello di Gianni Serra , 5-6 nov. Petrolchimico Marghera, 7-8 nov. ex Cantieri navali Giudecca, 9 nov. Tendone piazza Candiani Mestre, La Biennale di Venezia, ott.-nov. 1974
AA.VV. Fabbrica quartiere teatro: Otello a Marghera, a cura di Benedetta Bini, Lodovico Mamprin e Loredana Perissinotto, Gruppo permanente di lavoro per i rapporti con la scuola, La Biennale di Venezia, 1975.
La Biennale, Annuario 1975 del 1974, a cura dell’Archivio storico delle arti contemporanee, Venezia, 1975
Giorgio Manganelli, Tragedie da leggere, Tutto il teatro, a cura di Luca Scarlini, Nino Aragno Editore, Marene, 2005
Contiene il “Cassio governa a Cipro”.
Otello da William Shakespeare, testo di Giuseppe Bartolucci, fascicolo/programma di sala per l’ “Otello” di Memè Perlini, Biennale di Venezia, ott.-nov. 1974
William Shakespeare, Otello, commento di Agostino Lombardo, Ed. l’Unità, Roma, 1993
PASSANDO AI FILM
TESI DI LAUREA DI MARILENA GRIFO’
SUGLI ANNI DELLA RIFORMA PSICHIATRICA
SECONDO I FILM “I GIARDINI DI ABELE”, “MATTI DA SLEGARE”, “FORTEZZE VUOTE”
PER VISUALIZZARLA CLICCA SUL TITOLO
A SEGUIRE
INCOLLO LA PARTE DI MARILENA GRIFO’ DEDICATA IN PARTICOLARE A
FORTEZZE VUOTE
FORTEZZE VUOTE
UMBRIA: UNA RISPOSTA POLITICA ALLA FOLLIA
Dal regolamento dei Centri di igiene mentale della Provincia di Perugia
Art 1- L’esperienza dei servizi psichiatrici della Provincia di Perugia si è realizzata nella lotta contro l’internamento psichiatrico e contro le istituzioni segreganti
Art 2- La salute mentale si tutela, non espandendo strutture e servizi psichiatrici, ma trasformando profondamente le condizioni ed i significati della vita associata in modo da realizzare rapporti umani e modelli socio-culturali che pongono il benessere dell’uomo quale valore primo e fondamentale.
Si costruisce anche nell’ambito della lotta collettiva e individuale contro lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo e contro tutti quegli ostacoli, materiali e culturali, che impediscono il pieno e critico dispiegarsi della personalità umana.
Su un manifesto sul quale sta scritto: “CHI DISTURBA IL SISTEMA E’ MALATO” scorrono queste parole. E’ così che inizia il film Fortezze Vuote, in una simbolica e chiara coincidenza di principi ispiratori dei Centri di igiene mentale della Provincia di Perugia e del film stesso. La finalità prima è dunque subito esplicitata: si tratta di un documentario di informazione in cui emerge forte la richiesta di partecipazione della società alle decisioni e ai processi politici e l’importanza della comunicazione come momento fondamentale della vita associata.
Il titolo, che appare subito dopo, simbolizza l’istituzione manicomiale messa in crisi e lo fa riprendendo una definizione che Bruno Bettelheim diede della condizione in cui vengono a trovarsi i malati mentali affetti da autismo, cioè individui che, per ragioni non ancora spiegate, “improvvisamente si rinchiudono in se stessi, alzano una barriera contro la realtà e subiscono, di conseguenza, una drammatica regressione”, arroccati in una solitudine e in un’impossibilità di esprimersi (se non a livelli elementarissimi), come fossero murati vivi in una fortezza, appunto, desolatamente vuota. In questa sovrapposizione tra l’immagine di una malattia e l’immagine del manicomio è già racchiusa l’idea dell’istituzione che crea alienazione ed è produttrice di malattia.
Negli appunti di lavorazione del film che ancora conserva il regista Gianni Serra leggiamo:
“Il manicomio – che quando fu istituito apparve come il segno della nuova egemonia borghese, scientifica e umanitaria contro le vecchie superstizioni – non è un “luogo terapeutico”: è un luogo di segregazione e di esclusione, un luogo di violenza istituzionalizzata per poveri, derelitti, alcolizzati, minorati.
Ogni giorno la cronaca si fa portavoce di casi tragici che testimoniano condizioni spaventose di gestione o più semplicemente la morte civile, la spersonalizzazione, la regressione automatica, il meccanismo di violenza che l’istituzione in quanto tale provoca e alimenta.
Il documentario intende raccogliere le testimonianze della tortura di questa condizione umana, e di questa violenza, in un Ospedale psichiatrico “liberalizzato” già da dieci anni e oggi in totale smantellamento: quello della città di Perugia. E vuole anche fare un’indagine sui problemi e sulle difficoltà che ora si presentano per gli ultimi ricoverati in attesa di essere dimessi, (…) illustrando parallelamente il processo di grande importanza sociale che ha visto la creazione in Umbria di un servizio psichiatrico alternativo…”
L’esperienza umbra
Nel corso del decennio che andava dal 1964 al 1973 si era sviluppato in Umbria un processo di profonda ristrutturazione dei servizi psichiatrici, a partire dalla semplice idea di razionalizzazione del sistema tradizionale fino ad arrivare al totale ribaltamento della sua impostazione e ideologia.
Veniva gradualmente disfatto il manicomio di Perugia, i suoi padiglioni venivano trasformati in sedi di servizi sociali e scuole e il muro di cinta abbattuto. Se nel 1964 i ricoverati erano 1.113, nel novembre del ‘73 erano rimasti 419. Nel frattempo si erano creati in tutto il territorio 10 centri di igiene mentale, di cui il primo nasceva già nel 1968, mentre a Perugia, Città di Castello, Assisi e Foligno venivano costituiti i gruppi-famiglia la cui gestione andava affidata ai servizi sociali dei comuni.
Questo processo di trasformazione coinvolse anche le altre istituzioni segreganti come le classi speciali, i brefotrofi, le case di rieducazione, gli istituti per handicappati ecc…
Il processo era frutto, come sarebbe emerso dal documentario, di una lunga mediazione politica e di un dibattito che coinvolse profondamente la società.
Così possiamo leggere nelle schede del film di allora che:
“L’amministrazione provinciale di Perugia (PCI-PSI) ha posto una condizione fondamentale per il superamento dell’istituzione manicomiale: il coinvolgimento di tutte le forze politiche antifasciste, delle varie istanze della società, degli operatori psichiatrici, dei cittadini, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e culturali”
Genesi di un documentario collettivo
Quando nel 1974 la regione Umbria e l’amministrazione provinciale di Perugia si posero l’obiettivo di fornire una testimonianza pubblica del lavoro svolto in campo psichiatrico era stato da poco prodotto il film di Gianni Serra Dedicato a un medico, proiettato nella stessa Perugia durante il festival dell’Unità.
“ “Dedicato a un medico” fu un lavoro su commissione prodotto dalla RAI. Allora la psichiatria non rientrava nei miei interessi, che erano sociali e politici. Di fatto mi fu proposta una sceneggiatura che nasceva dall’esperienza di Basaglia in un periodo in cui tutto il suo operato era divenuto un fatto politico dirompente e rivoluzionario che andava aldilà del fatto medico e psichiatrico.
Il film, in cinque puntate, fu poi censuratissimo dalla televisione all’epoca di Bernabei in cui la RAI produceva e si auto-censurava. Così “Dedicato a un medico” ebbe una duplice risonanza, divenendo anche la base per un movimento di riforma della televisione e della cacciata di Bernabei. Ecco anche perché fu invitato a molti festival. Quando poi finalmente lo diedero in televisione andò in onda in contemporanea alle partite dei mondiali di calcio” (Gianni Serra, intervista rilasciata il 21 dicembre 2004)
La proiezione a Perugia fu l’occasione per proporre a Serra il film e impostare assieme a lui un progetto. Così Giuseppe Pannacci, allora assessore ai servizi psichiatrici della provincia di Perugia, Gianni Serra e Dario Natoli, allora direttore dell’Unitelefilm misero a punto un piano produttivo che prevedeva il contributo finanziario della Provincia e della Regione.
Il progetto che fu approvato allora prevedeva un film-inchiesta con una parte “narrativa” di fiction.
Ai primi del gennaio 1975 Serra e i suoi collaboratori, Gioia Benelli e Tomaso Sherman, si recarono a Perugia per iniziare la preparazione del film. Dopo molte riunioni – con gli operatori del CIM (Centro di igiene mentale), il direttore dei servizi psichiatrici Francesco Sediari, l’assessore Pannacci e molti esponenti della Commissione consigliare – vennero identificate alcune linee fondamentali sulle quali il film avrebbe dovuto svilupparsi. A questi incontri ne seguirono altri nell’Ospedale psichiatrico, nei gruppi famiglia, nelle case degli ex ricoverati, in tutte le sedi dei CIM, nei quartieri e nelle fabbriche.
Fu così che, di fronte alla complessità della realtà che di giorno in giorno andavano scoprendo e vivendo, si decise di proporre una struttura cinematografica aperta e cioè che rispettasse e riflettesse in qualche modo il metodo che era stato seguito dai veri protagonisti del processo. Si abbandonava così la strada, proposta all’inizio, del film narrativo, d‘autore, per un’opera che fosse veramente il risultato di un contributo collettivo. L’impostazione realizzativa, concordata e approvata in una riunione definitiva, portò alla convocazione immediata dell’Assemblea popolare: cittadini, malati, operatori psichiatrici, consiglieri provinciali, sindaci, assessori dei comuni e della regione, fornirono con i loro interventi i contenuti e le linee programmatiche del film stesso. Gli interventi, che vennero filmati, avrebbero costituito l’ossatura del documento cinematografico e sarebbero stati vincolanti per le successive scelte.
“All’epoca c’era il mito del film collettivo che doveva essere frutto non di un autore ma di un collettivo appunto. Fortezze vuote nasce su questa linea. In effetti è stato il frutto di una mediazione tra le varie forze politiche, democristiani compresi. Il mio quindi non è stato un lavoro d’autore ma non la sentii come una diminuzione. Ero realmente interessato a quel tipo di esperienza.
La gestazione fu assai curiosa e innovativa. Io, Gioia e Tomaso andammo a Perugia a organizzare questa prima assemblea dalla quale sarebbero dovute venir fuori le linee guida del film. Poi ci fu un bel periodo in cui studiammo e discutemmo per ore e ore su cosa fare, assieme anche a Manuali e agli altri, e facemmo un lavoro sul territorio. Di volta in volta andavamo a cercare quei casi che ci venivano segnalati di utenti passati o in cura presso i CIM o dimessi dall’ospedale psichiatrico, oltre a quelli che restavano ancora dentro.
Fu un lavoro lungo e capillare, di circa quattro mesi, di documentazione cosiddetta democratico-collettiva e di identificazione dei casi, scelti anche in base a simpatie o antipatie, ma non solo. Fortezze vuote fu, ed è tuttora, interessante soprattutto per il processo organizzativo della mediazione politica. Prendiamo ad esempio la sequenza del prete: questi c’era stato segnalato da un operatore, come rappresentativo di una realtà importante, specialmente in una società contadina dove il parroco deteneva un ruolo e un potere molto forti. Beh, quella sequenza, momento di rilassamento e gioia durante le proiezioni che facevamo, era in origine molto lunga. Fu un rappresentante dei democristiani che mi chiese di ridurla, di non darci troppo “dentro” e così feci”.”
(Gianni Serra, intervista rilasciata il 21 dicembre 2004
Nella scena a cui si riferisce qui il regista viene intervistato un prete di un piccolo paesino sulla situazione di un uomo che era stato pesantemente emarginato prima di essere rinchiuso in manicomio. Come è facile immaginare il prete fa una pessima figura rispondendo in modo aggressivo e ottuso.
Il meta-documentario
Dopo tre settimane di riprese il materiale raccolto consisteva in più di venticinquemila metri di pellicola. Dopo quattro mesi di lavoro fu montato uno della durata i circa tre ore. Ma prima di passare al montaggio Gianni Serra pose il problema se voler proseguire con l’ipotesi di fare emergere il processo di fattura del film o abbandonarla.
“…Allora io dissi a Manuali che l’esperienza che avevamo fatto era stata molto bella ma che da un punto di vista d’autore secondo me dal film doveva essere eliminata tutta la parte didascalico-assemblearistica. Gli spiegai che a mio parere quella parte era inutile, pedagogica, e che si sarebbe fatto un lavoro più importante coinvolgendo il pubblico con discorsi non politici o teorici ma con le testimonianze che avevamo, che erano intensissime e dense di significati senza bisogno di appellarsi a inutili esplicazioni.
Manuali non fu d’accordo. Ci consultammo e alla fine si decise di lasciarle. Così in fase di montaggio cercai di rappresentare il processo senza sacrificare troppo le testimonianze.
Quando il film fu finito Manuali mi diede ragione e disse che se ci fossimo sbarazzati di tutta l’impalcatura teorica avremmo avuto molta più efficacia. Oggi invece, a trent’anni di distanza, posso dire che in realtà quei momenti assembleari hanno una loro forza ed efficacia che va aldilà dell’intento didascalico e sarei meno critico” (Gianni Serra, intervista rilasciata il 21 dicembre 2004)
Una seconda Assemblea Popolare fu infine convocata per discutere il lavoro, indicare modifiche e tagli, arrivando così a un film di circa un’ora e mezza.
Il documentario appare quindi montato su due livelli di narrazione. Il primo ha per oggetto la ristrutturazione dei servizi psichiatrici attraverso le testimonianze di chi era direttamente interessato da questi cambiamenti. Il secondo ha per oggetto la genesi del film stesso con la scelta e la discussione dei suoi contenuti. L’assemblea cittadina e le riunioni presso i CIM, che fanno da collante di tutto il film, esprimono questa narrazione dentro la narrazione.
Il rischio, come espresso dallo stesso regista, era quello di diventare didascalico e pedagogico. Eppure c’era una forza in quella scelta: quello che era un mito, del film non autoriale e dell’esperienza collettiva, diventava qui qualcosa di più: era cioè una riproposizione in qualche modo dell’esperienza sociale e politica che aveva portato a quella ristrutturazione dei servizi psichiatrici in Umbria. La parte per così dire didascalica riesce a gettare luce sull’oggetto principe del film trovando così una giustificazione e una forza che vanno al di là della sperimentazione avanguardistica e della motivazione di autopromozione della Provincia di Perugia e della Regione, pur presenti.
Basaglia e Manuali a Venezia
Nel 1975 “Fortezze vuote“ debuttò alle giornate del cinema di Venezia, come, in seguito alle lotte sessantottine, per eliminare i leoni, si chiamò quello che prima era il Festival.
Il pubblico, come si può leggere nei giornali di allora, seguì la proiezione del film di Serra, in Campo Santa Margherita, con partecipe e solidale attenzione: “Fortezze vuote è stato fatto oggetto (…) di una appassionata discussione incentrata non tanto e non solo sui motivi specifici posti in risalto dal documentario, ma proprio su tutte le vaste e ramificate correlazioni sociali e politiche che in esso emergono.”
Al dibattito erano presenti sia Franco Basaglia che Carlo Manuali, la mente della ristrutturazione dei servizi psichiatrici di Perugina: “Ci fu uno scontro molto bello tra i due, uno scontro di ideologie: Basaglia sosteneva che i processi di ristrutturazione dovessero nascere all’interno del manicomio, che ci dovesse essere una sorta di esplosione del manicomio. Manuali gli rispondeva che doveva essere una distruzione fatta dall’esterno.”
Fortezze vuote è molto significativo nell’ambito di una ricerca sulla comunicazione della rivoluzione basagliana proprio perché in qualche modo se ne distacca e racconta di un processo diverso e contemporaneo.
In realtà, secondo Gianni Serra, si trattava di uno scontro d’amore: “il principio era identico e la finalità era identica .. i mezzi e l’ideologia differenti…Per sintetizzare in Basaglia c’era il matto come eroe che vuole abbattere i muri del manicomio e lo fa. In Umbria c’era un discorso opposto: la preparazione del territorio, la creazione delle strutture esterne, la sensibilizzazione della società civile e della gente in modo che fosse la gente dall’esterno ad abbattere le mura del manicomio d’accordo con gli operatori e con gli ospiti più coscienti del manicomio… Io a quel tempo ero molto legato all’ideologia basagliana: la parte anarchica e individualista che c’era in Basaglia la sentivo più vicina a alle mie idee politiche che non la componente della mediazione politica. Eppure come negare la giustezza del procedimento umbro.” (intervista rilasciata il 21-12-04)
A questo proposito è interessante anche la risposta che Manuali da a Serra nel film quando questi gli chiede se ci fosse stata l’influenza di Basaglia.
“Noi stiamo parlando di un periodo di almeno tre o quattro anni antecedente all’esplosione del problema manicomiale nella prospettiva in cui è stato posto da Basaglia. Di fatto, poi Basaglia ha avuto una certa influenza su alcuni operatori. C’è stata per un momento l’illusione che i capitalismo avesse in qualche modo corrotto, occultato, riassorbito la capacità della classe operaia di mutare la società. E allora ecco c’è stato uno spostamento: il potere eversivo della classe operaia è stato trasferito sul folle. Il folle sembrava l’ultimo testimone della contraddizione sociale. Da qui è stato, anche abbastanza semplicisticamente, contrapposto il folle alla società“.
Uno schema semplice
Il documentario segue un filo logico e una costruzione serrati, più di quanto non possa apparire a una prima visione.
Di fatto i temi si sviluppano, semplificando, nel seguente modo: dopo un sunto e un’introduzione sull’esperienza umbra, si tenta di ricostruire alcuni aspetti della realtà manicomiale: le mura, la mancanza di libertà, le terapie choccanti, i metodi di contenzione. Vengono intervistati infermieri, ospiti o ex ospiti dell‘ospedale psichiatrico di Perugia.
Non c’è qui, come ci si potrebbe aspettare, nessuna morbosità e nessun accanimento nel rendere con immagini, visive o mentali, cruente, la natura mostruosa e criminale della “detenzione”. Non ci sono fantasmi da riesumare, medici mostruosi o infermieri-macchina.
Subito dopo si affronta il tema del cambiamento: chi erano i protagonisti e da quali esigenze e convergenze nascesse questo processo di razionalizzazione dei servizi psichiatrici (come all’inizio venne chiamato).
E quindi il tema della mediazione politica e della partecipazione dal basso, tramite anche interviste girate in strada.
Poi si affronta il vero problema, quello cioè ritenuto allora più attuale: la riorganizzazione dell’esperienza di vita di queste persone.
Viene discusso e mostrato come funzionano le case famiglia. Si parla dei problemi relativi all’inserimento nella società di questi soggetti: problemi legati al lavoro, alla difficoltà nel lasciare il manicomio, all’accettazione di una vita autonoma, con delle responsabilità e libertà, ma anche allo squallore della realtà. E’ in questa fase che emerge la tesi umbra forte della terapia come proposta di realtà.
Fino ad arrivare alle altre istituzioni segreganti: i brefotrofi e le scuole differenziali.
Come si è già detto il film passa da momenti assembleari, in cui però non c’è un vero e proprio dibattito, ognuno è portavoce di se stesso o del proprio gruppo politico, a momenti di indagine delle realtà descritte, attraverso le testimonianze, con una corrispondenza puntuale tra l’elemento critico emerso dall’assemblea e il caso specifico nella sua complessità e singolarità.
Questa struttura, probabilmente emersa dalla stessa assemblea cittadina iniziale, rispetta un discorso, un filo logico, sul quale si innestano tante storie. Quella di Marta che non vuole più andar via dal manicomio, quella una dolce e giovane donna che va a spasso perché non ha un lavoro e prende “solo” due pillole, per distendere, e che era entrata in manicomio in seguito a un esaurimento nervoso. Poi c’è la storia di Zeffirino che piange piange piange e che si scopre vivere isolato con la famiglia in una cascina senza nessuno con cui parlare. C’è Giovanni, triste e di poche parole, che pare fosse stato rinchiuso in un castello prima di andare in manicomio per problemi politici o per via di una donna o per via di certe stranezze che nessuno racconta, men che meno il prete…
E poi c’è Marco che scrive musica e che non sa come farsi aiutare.
E’ in queste testimonianze la forza emotiva del documentario, non perché muova a sentimenti di compassione. Non c’è una diversità, una abnormità che giustifichi questo sentimento, non c’è neanche l’esigenza di riscattare queste persone da un peccato originale invocando l’anima candida o la creatività artistica o altro. Emozionano perché sono terribilmente e stupendamente umani. Perché le cose che dicono risultano a qualcuno a volte comprensibili e a volte no.
Non c’è insomma il folle saggio né il folle artista né il folle vicino a Dio (come era stato per i lebbrosi), c’è invece il folle umano e l’umana realtà, anche un po’ squallida.
L’ideologia esplicita
Ognuno di questi passaggi che costituiscono la storia della ristrutturazione dei servizi psichiatrici umbri, e che hanno segnato la vita di molti individui, è letto secondo una precisa ideologia resa esplicita in altrettanti momenti.
Punti fondamentali di questa ideologia sono i seguenti:
- •Il manicomio deriva da un’ingiustizia sociale figlia dell’egemonia borghese
“Come la istituzione del manicomio nel 1823 a Perugia fu il segno della nuova egemonia borghese… così le trasformazioni effettuate in questo decennio nella regione dell’Umbria riconducendo i servizi psichiatrici alla loro finalità terapeutica modellandoli sui bisogni di una società democratica, sono il segno di una egemonia nuova che esprime gli interessi di fondo della classe operaia e delle masse lavoratici”
- •Era necessario passare dall’istituzione custodialistica a quella terapeutica attraverso un processo di partecipazione sociale che privilegiasse il momento “esterno” dell’intervento sul territorio, piuttosto quello “interno” all’ospedale psichiatrico: “Si rifiutava in questo modo ogni atteggiamento illuministico e di aristocratico distacco dalle organizzazioni dei lavoratori, dalle autonomie locali; si rifiutava lo spostamento élitario, la strumentalizzazione del malato di mente, considerato dagli altri come forza d’urto, forza rivoluzionaria…”
- •La gestione della follia è SEMPRE una questione sociale
E’ Manuali, lo psichiatra che aveva guidato il processo di ristrutturazione dei servizi psichiatrici di Perugia, che si fa molto spesso portavoce esplicito (o tale è il suo ruolo nel film) di questo aspetto. Così spiega a Gianni Serra durante un’assemblea di un CIM :
“L’essere malati di mente è prodotto di un’ingiustizia sociale”
Serra: “Sempre?”
Manuali: “Sempre di un’ingiustizia sociale…”
Serra: “Non esiste un problema biologico, organico?”
Manuali: ”Quando il problema biologico e organico esiste, è documentabile, allora la domanda si pone in termini diversi; che cosa fa la società di una persona che trova difficile realizzare se stessa. Cioè quello che io mi chiedo, non è tanto le caratteristiche di quello che, in una parola, potremmo chiamare handicappato, ma quello che fa la società dell’handicappato, che cosa fa la società per lui. Quindi la domanda è sempre una domanda che va rivolta alla società, non all’individualità biologica del soggetto”.
Ed è sempre lui a parlare di terapia…
- •La terapia come proposta di realtà
“La terapia non è una proposta di felicità ma è una proposta di realtà. E quindi, essendo una proposta di realtà, noi per questi soggetti non possiamo se non organizzare un modello di vita o dei modelli di vita così come sono i modelli di vita delle persone simili a loro. (…) Quindi lo squallore che voi avete trovato nei gruppi famiglia è lo stesso squallore che avete visto a casa di Battolini (indica un utente del CIM di Castello, presente al dibattito)… non è squallido il gruppo famiglia, è squallida la realtà, è squallida la realtà in cui è costretta a vivere la gente. L’unico modo per fare qualcosa di positivo è quello di congiungere questi squallori, di farne uno squallore unico e quindi una proposta di trasformazione sociale unica”
La storia di Marco
Il film si apre e si chiude con l’immagine dello stesso giovane. Si chiama Marco Zangarelli.
Le sequenze che lo riguardano sono incredibilmente forti, eppure lui non racconta molto di sé, non dice cosa lo affligge, non parla del suo male benché lo riconosca. E’ ritratto in momenti di sofferenza e di abbattimento ma anche in momenti più sereni. Sembra racchiudere il mistero che si cela dietro la sofferenza mentale nell’alternanza di momenti di comunicazione possibile e momenti di incomunicabilità, nei quali emerge una impotenza avvilente sua e di chi gli sta attorno.
La prima immagine che abbiamo di lui è quella di una persona che soffre è che è confusa. Sta entrando in una stanza accompagnato da altre persone, siamo presumibilmente all’interno di un centro di salute mentale. Piange, si siede e si copre il viso. E dice: stanno riprendendo il matto, stanno riprendendo il matto di Città di Castello…
Subito dopo un’immagine più serena, il suo viso porta delle ferite recenti ma è disteso. Gianni Serra gli chiede di suonare alcune musiche che verranno usate nel documentario. Ecco che il farsi del documentario ne diventa parte integrante e in modo particolare qui non per una casualità ma per una sorta di necessità, perché non poteva essere altrimenti, per la sua incredibile intensità e umanità.
Marco suona delle musiche sulle quali vengono montate le immagini che Gianni Serra richiama alla sua mente: quelle della campagna povera, quelle del manicomio, quelle di una giornata allegra e di una passeggiata in città ecc…
E alcune di queste immagini, dure e scioccanti, acquisiscono un valore diverso. È come se l’intrusione dell’estraneo, lo spettatore in questo caso, fosse addolcita, resa meno invasiva da questa persona che, in una posizione in bilico tra il dentro e il fuori, ci guida con il suo sguardo, espresso dalla sua musica, in quel mondo che è l’interno del manicomio.
Sul finire il documentario torna a Marco, alla sua storia. Lui parla di sé adesso e dice che non basta il CIM per aiutarlo, che lui avrebbe bisogno di una ragazzina, non solo per fare l’amore, ma che lo capisca.
Subito dopo siamo sempre al CIM e si viene a sapere che Marco ha appena avuto una crisi, nel negozio della madre. Due operatori vanno per aiutarlo. Quando arriva al CIM è sconvolto, ha la maglia strappata e piange disperato. Così la madre dice che una crisi così forte non l’aveva da tanto tempo o forse non l’aveva mai avuta e che aveva bevuto.
Una voce fuori campo su delle immagini di lui che suona a casa sua, presumibilmente è uno psichiatra o un operatore, racconta la sua storia e così scopriamo che Marco ha avuto una lesione da estrazione col forcipe alla nascita ma che i suoi problemi di allora non erano legati a questo bensì all’emarginazione di cui era stato vittima sin da piccolo a scuola, accusato e isolato per fatti che non lo riguardavano.
Si parla così di una lesione ma si abbraccia la tesi espressa da Manuali del problema comunque sociale del disagio. Si chiama in causa quindi l’istituzione segregante, che può essere qualsiasi istituzione.
Il film si chiude con uno spezzone di una riunione in cui Marco, i genitori, i vicini di casa, gli operatori e lo psichiatra discutono insieme sulla sua situazione e si chiedono come affrontarla , cosa fare per lui. Sul finire uno psichiatra dice: “forse lui potrebbe dirci come aiutarlo, cosa potremmo fare noi per lui”. Ma lui non risponde, non lo sa, è confuso.
Quando il documentario fu adattato per la televisione tutta questa parte non andò in onda in quanto Marco Zangarelli non volle comparire in televisione. Essa però racchiude in sé molto di quello che emerge dal documentario nel suo complesso ed è per questo che l’abbiamo voluta descrivere. L’irrazionalità, nel senso di incapacità nostra di comprenderla e razionalizzarla, della sofferenza psichica. La descrizione puntuale dell’approccio teorico e pratico dei servizi psichiatrici umbri (come agiscono nel momento di crisi, quali proposte di convivenza fanno ecc…). L’elemento della responsabilità sociale e della chiamata in causa della società stessa nella ricerca di risposte quotidiane al disagio del giovane. La comunicazione partecipativa e orizzontale cui inevitabilmente fanno parte coloro che girano il documentario nel momento stesso in cui lo girano.
Quali parole per il disagio psichico
Come già detto esistono diversi livelli narrativi: quello dell’assemblea, quello delle singole testimonianze o interviste di operatori, di gente per strada, di ospiti o ex ospiti dell’ospedale psichiatrico ecc…, che sembra un’appendice del primo livello, sono cioè interventi che approfondiscono quanto emerge nell’assemblea. Infine c’è quello delle storie di cui si è già parlato. Quello che qui interessa è capire da chi e come vengono raccontate queste storie. I narratori sono per lo più diegetici, fanno cioè parte della storia stessa che raccontano e sono principalmente: il soggetto protagonista, è l’utente dei servizi dei CIM, i parenti stretti, i vicini di casa o i compaesani. I narratori extra-diegetici raccontano invece una storia che hanno ricostruito ai fini terapeutici, sono cioè i medici e gli operatori che raccontano la natura del disagio della persona. Sono questi che usano termini medici ma il modo in cui lo fanno è significativo. Privilegiando infatti l’interpretazione sociale del disagio, quando vengono usate parole come: depressione o delirio di rovina o autismo, esse vengono contestualizzate in modo preciso all’interno di un linguaggio specialistico e di un mondo semantico classificatorio dei sintomi.
Così ad esempio, nel caso di Zeffirino. Siamo in una stanza di un CIM, sono presenti Zeffirino, uno psichiatra e Gianni Serra che chiede di cosa soffra Zeffirino. Lo psichiatra risponde:
“Nella psichiatria classica viene chiamata una sindrome depressiva” … “Zeffirino presenta altri sintomi… secondo il linguaggio della psichiatria classica questi sintomi vengono definiti come delirio di rovina”
e dopo… “Bisogna superare il sintomo psichiatrico di Giovanni per investire in un’analisi della sua realtà di tutti i giorni, cioè il mondo contadino e la sua crisi…”
Al linguaggio psichiatrico classico non si sostituisce quindi un nuovo linguaggio ma la necessità del superamento del sintomo psichiatrico attraverso l’analisi e l’azione nel sociale. Il testo parlato del documentario risulta così estremamente coerente con l’ideologia, con un rischio di semplificazione che rispecchia bene l’esigenza comunicativa dell’amministrazione provinciale di Perugia e regionale umbra
Quando parlano della loro storia spesso non fanno un’analisi sociale. Si danno nella loro esperienza fatta di sofferenze, di traumi, ma anche di speranze, di bisogni o rassegnazioni. Così c’è Marco che avrebbe bisogno di una ragazza, una giovane donna che vuole un lavoro e Marta che non esce dal manicomio se non ha una casa tutta per sé e magari un fidanzato giovane e ancora qualcuno che nonostante le difficoltà si sta abituando alla vita fuori anche perché: “il peggio deve ancora venire”. Sono loro infine che nominare la terapia farmacologia e raccontano quali pillole prendono. Mentre gli psichiatri non ne parlano mai.
CONCLUSIONI.
Aldilà delle differenze, spesso forti, che caratterizzano i tre documentari, si può fare ora un discorso generale sul loro significato e tentare una lettura odierna di certi nodi teorici e pratici emersi dalla loro storia e struttura.
Ciò che essi facevano, se così si può dire, era documentare un processo rivoluzionario. La loro singolarità è quella di mettere in atto una comunicazione possibile e inedita. In questo senso la testimonianza costituisce la forza comune dei documentari, il momento dell’atto, dell’unico evento che è proprio solo del mezzo documentario. Inutile scomodare le teorie sociologiche di comunicazione sull’intervista e sul testo audio-visivo. Si potrebbe dire che in questo caso il senso più forte, aldilà del testo, sia di natura pragmatica: l’atto comunicativo è forse il concetto che più si avvicina a questa situazione. Per la prima volta viene chiesto a una persona emarginata e spogliata dei propri diritti e della parola, reclusa in una realtà, quella manicomiale, dove la comunicazione è assolutamente verticale ma soprattutto a senso unico, di raccontare la propria storia ad altri, che non sono solo gli operatori, i medici o i familiari, bensì un pubblico generico. Se a partire dagli esperimenti di comunità terapeutica già all’interno dei manicomi si abbattevano le barriere comunicative, veniva restituita la parola a queste persone, è con questi documentari che l’interlocutore non è più il tecnico che dovrebbe prendersi cura di lui ma è ipoteticamente l’intera società. L’impatto emotivo infatti di queste testimonianze è fortissimo e non solo perché spesso raccontano con inaspettata lucidità lo stato di brutale isolamento e umiliazione e violenza a cui erano stati sottoposti, ma perché abbattono con la loro intensità comunicativa qualsiasi distanza supposta o voluta tra “sano” e “malato”. Così quando Pietro, il giovane ragazzo intervistato da Zavoli spiega quali siano i suoi desideri e le sue aspettative, quando Marco, in Fortezze vuote, racconta di aver bisogno di una ragazza che lo capisca o Paolo, il bambino con la cui storia inizia Matti da slegare, dice di voler essere lasciato in pace e di voler lavorare, risulta fin troppo facile, immediato, sentire questi bisogni tanto vicini ai nostri. Così la lontananza si annulla in un modo incredibile grazie ai meccanismi di identificazione propri del cinema e nonostante l’ ”intrusione”, solo apparente, dell’intervistatore. La sua presenza, pare, fa sì che non si abbia l’illusione di straniamento dalla realtà. E’ il nostro sguardo che a volte con paura, con curiosità, con coinvolgimento o semplicemente umana comprensione si avvicina a queste persone tramite un “nostro” testimone. Non sono quindi ritratti di un “dentro” dal di “fuori” ma testimonianze di un incontro reale e quindi umanamente difficile, tra il dentro e il fuori, tra l’escluso e l’escludente, tra il normale e il diverso, incontro in cui si sciolgono queste categorie in un modo più forte e pregnante di qualsiasi discussione teorica o di qualsiasi testimonianza mediata da altri mezzi di comunicazione. In questo incontro ancora il manicomio, come qualsiasi istituzione segregante, svela il suo palco, le sue bugie, svela una debolezza enorme che sta tutta fuori. Svela le nostre paure più lontane e la miseria di una società che si fonda sulla necessità dell’omologazione e della produttività.
Qui preme sottolineare il valore comunicativo di questi film. Essi da un lato esprimevano e documentavano esperienze contemporanee creando consenso e cercano di abbattere i luoghi comuni, gli stereotipi, le resistenze a quanto veniva fatto, seppur con diversi approcci teorici e pratici, nelle diverse città. In questo senso il loro ruolo è da leggersi nel contesto storico, politico e culturale di quegli anni, come più volte hanno sottolineato gli stessi registi, e, sempre in questo senso, ha valore il singolo documentario come parte di un processo più complesso che aveva molti protagonisti: gli psichiatri, i politici, gli amministratori, gli operatori, i registi, la società, gli utenti degli allora nascenti CIM (Centri di igiene mentale). Si tratta di un’esperienza che va ben oltre la produzione del film e che comincia con il desiderio e la consapevolezza di alcuni della necessità di portare fuori l’esperienza che si stava vivendo. Un fuori che non era solo il bacino sociale nel quale si stimolava e sviluppava il cambiamento, ma era tutta l’Italia. A tal proposito è significativo quanto si legge sulle possibilità di uso del film Fortezze vuote che nella sua schematicità sottolinea come ci fossero realmente diversi livelli di comunicazione (oggi diremmo diversi target) e finalità:
“C’è una prima ipotesi che riguarda un uso diretto del film (…) per proseguire l’azione di coinvolgimento di massa, attraverso la discussione e l’impegno operativo, di tutta la collettività umbra. (…) Una seconda ipotesi prevede l’allargamento di questa azione su tutto il territorio nazionale, ricorrendo a quell’ampio circuito cinematografico – già permanentemente utilizzato dall’Unitelefilm – che poggia soprattutto sul movimento associazionistico. Una terza ipotesi prevede il raggiungimento ed il coinvolgimento di un pubblico ancora più ampio, con una azione tesa ad impegnare in primo luogo le strutture politiche di comunicazione; e fra queste in particolare la Rai-Tv. Resta, infine, una quarta ipotesi, per l’uso dei materiali non utilizzati nel film… Per questi è progetto comune di quanti hanno contribuito a realizzare “Fortezze vuote”, di operare una riorganizzazione del materiale al fine di produrre una serie di documenti scientifici a disposizione di chiunque operi specificamente nel campo della riforma e ristrutturazione delle istituzioni psichiatriche, in Italia e all’estero.”
Un’esperienza inoltre che fu, nel caso di Matti da slegare e Fortezze vuote, di tipo collettivo, come si è visto e che forse di per sé rendeva giustizia di una complessità e di un campo di confronto aperto e vivo.
Non solo. L’esperienza sarebbe continuata per almeno due anni con una distribuzione del film che, come è stato detto più volte, seguì un percorso alternativo e vario coinvolgendo le varie cittadinanze d‘Italia in assemblee accese. La forza comunicativa di questi documentari non può esaurirsi quindi nell’analisi del testo-documentario bensì nella spinta al dibattito che diedero laddove queste esperienze non erano vicine. Mentre, laddove raccontavano una storia vicina, ebbero forse il ruolo di rafforzare un sentimento di riappropriazione da parte della società del proprio destino e della possibilità di mutare e trovare alternative nuove per la convivenza.
E poco importa se, come dice Petraglia (e come si è approfondito nel capitolo dedicato a Matti da slegare), il lavoro presentasse molte ingenuità: era necessario in quel momento comunicare che l’abbattimento dei manicomi fosse possibile e che non si poteva tornare più indietro.
Oggi questi documentari ci parlano di una sola parte di quel processo: ci dicono quali fossero le ideologie che li supportavano. Presi nel loro complesso ci parlano degli elementi di dibattito, delle diversità di approccio.
Sia la storia di questi documentari così come è stata, a volte sommariamente, ricostruita, che i testi stessi fanno infine emergere alcuni nodi di questi confronti, alcune contraddizioni della società e del suo modo di gestire la salute mentale e le diversità che sono tutt’oggi presenti e per certi versi irrisolte.
Quello che si vorrebbe ora provare a fare è riprendere alcuni di questi spunti emersi da questo pezzetto di storia alla luce di alcune posizioni espresse attualmente. L’analisi non vuole essere per nulla esaustiva.
Tra follia e malattia mentale
Carlo Manuali, l’abbiamo già ripreso ma vale la pena ricordarlo, dice a un certo punto:
“C’è stata per un momento l’illusione che il capitalismo avesse in qualche modo corrotto, occultato, riassorbito la capacità della classe operaia di mutare la società. E allora ecco c’è stato uno spostamento: il potere eversivo della classe operaia è stato trasferito sul folle. Il folle sembrava l’ultimo testimone della contraddizione sociale. Da qui è stato, anche abbastanza semplicisticamente contrapposto il folle alla società”
La parola follia è una parola che racchiude molteplici significati, è un campo semantico vastissimo che di per sé racconta se non tutto moltissimo della società che lo definisce.
Quello che è certo è che la sovrapposizione tra follia e malattia è qualcosa di relativamente recente. Risale infatti a un paio di secoli fa, quando la nostra cultura attribuì una definizione medica alla follia. Bisogna insomma risalire a Pinel, l’alienista francese che liberò i folli dalle catene separandoli dal resto degli scarti della società (siamo nel 1795) e investendo così il manicomio di funzioni terapeutiche connesse a una definizione della follia come una malattia dell’atteggiamento morale.
Nel corso dell’Ottocento i manicomi, al pari di quanto succedeva prima della liberazione di Pinel, che, occorre sottolinearlo, rimetteva ad amministratori e medici il dominio assoluto su questa libertà all’interno delle mura asilari, i manicomi si riempirono di persone che non erano, secondo la definizione di allora, “malate” bensì poveri, handicappati e vagabondi.
La storia della scienza psichiatrica sin dalle origini porta quindi con sé delle forti ambiguità. Necessariamente quando si parla dell’abbattimento dei manicomi si parla di follia più che di salute mentale, nel senso dell’aspetto eversivo della società: il folle non è l’artista eccentrico, non solo, non è chi soffre di disturbi mentali, non solo, non è il povero, non solo. È difficile individuare chi si vuole liberare. È difficile dare una descrizione, una definizione. Zavoli ci prova e parla di Abele, del fratello scomodo, ma è una metafora che riporta sempre alla condizione di escluso.
Questo è stato fonte nei dibattiti di certe ambiguità a livello sia teorico che pratico. L’ambiguità nasceva dalla distinzione, fuorviante nel contesto di un discorso antimanicomiale, tra definizione sociale e definizione medica della malattia. Essa non aveva a che fare direttamente con il superamento del manicomio. In questo sia Manuali che Basaglia erano d’accordo: la distinzione, in materia di abbattimento del manicomio, tra malattia organica o disagio sociale, non andava fatta non perché non fosse necessario un approccio terapeutico ma perché in quel momento la premessa a qualsiasi approccio “scientifico” era la liberazione dell’internato e il suo inserimento nella società. Nonostante ciò, gli avversari della riforma psichiatrica in atto facevano leva sul vuoto o sulle contraddizioni teoriche che caratterizzavano, e per certi versi caratterizzano ancora oggi, la psichiatria, per puntare il dito contro una scienza che delegava alla società la responsabilità del disagio psichico senza farsi carico di trovare ad essa una spiegazione scientifica, e magari una soluzione desiderata e non detta.
La risposta sociale alla follia è quindi in un certo senso una risposta che la società dà a se stessa perché la follia in quanto tale è frutto della società, ma non solo e non tanto per una semplificata relazione causale (per cui appunto l’irrazionalità del folle deriva dall’irrazionalità della società) quanto perché la definizione di follia è sempre una definizione sociale, è un appendice, è quello scarto che ogni società imperfetta produce, è la sua negazione e in quanto negazione forse il suo ritratto più lucido. Ecco perché la rivoluzione psichiatrica deve necessariamente passare per una rivoluzione sociale, e la definizione di “salute mentale” per una presa di coscienza della società. Questo elemento emerge in modo molto forte dall’esperienza di questi documentari e spiega bene la problematicità insita nella definizione della psichiatria all’interno di quegli eventi.
A volte succede, in questi documentari, che quando si parla di malattia o di cura, di rado in realtà, qualcosa rimane non detto, o meglio si mescolano due linguaggi che lo spettatore vorrebbe tenere separati. Così la proposta di realtà di cui Manuali parla diventa la terapia, ma terapia per quale malattia? Per la malattia istituzionale certo, ma questo non sempre viene detto in modo chiaro. Ricordiamo a proposito anche il meta-linguaggio utilizzato dagli operatori e dai medici in Fortezze vuote che, prendendo le distanze dal linguaggio della psichiatria classica lo utilizza per offrire comunque delle definizioni alle quali non vuole o non può rinunciare, senza rendersi conto forse che non è necessario in quel momento liberarsene, non avendo un’alternativa. Queste cose mettono in evidenza la forza dell’ideologia politica che, come hanno sottolineato Rulli e Petraglia, aveva portato a una semplificazione non del tutto voluta ma comunque strumentale a un certa volontà e prassi politica.
Manuali e Basaglia: il manicomio che si apre o il manicomio che si chiude
Pierangelo di Vittorio, nel suo articolo, “Tecnici di una società possibile”, prende spunto dal film di Zavoli per parlare del gesto rivoluzionario. Ne citiamo la parte iniziale:
“Siamo nel 1967, Franco Basaglia è direttore dell’ospedale psichiatrico di Gorizia. Ad un certo punto c’è una sequenza in cui si vedono dei pazienti (ma sarebbe meglio dire “internati”) che smantellano un muro, che abbattono delle grate, insomma che aboliscono fisicamente tutte quelle barriere che li tengono separati, esclusi dal resto della società. È la distruzione del manicomio, e si può leggere qui, nella sua espressione immediata, ma anche essenziale, il gesto rivoluzionario della psichiatria italiana.”
Subito dopo si pone due domande:
“1. «I manicomi si aprono o si chiudono?»: gioco di parole o nodo teorico? Quando abbatto le mura del manicomio sto lasciando uscire la follia, sto facendo ritornare la follia alla società? Oppure sto lasciando entrare la società, sto facendo ritornare la società alla follia?
…
2. «Chi apre o chi chiude i manicomi?»: i manicomi li aprono o li chiudono i pazienti o gli psichiatri, la gente che è rinchiusa nel manicomio o i tecnici che lo fanno funzionare? Nella sequenza cui facevamo riferimento, infatti, noi vediamo la gente che si libera, ma continuiamo a presupporre, dietro le quinte, la presenza dei tecnici, cioè di Basaglia stesso.”
Queste domande lo portano così a un’analisi del rapporto tra follia, tecnici e società.
Questo illumina ancora una volta sui conflitti ideologici che emergono dai diversi documentari. Come sottolinea Di Vittorio però la contrapposizione follia/società va risolta in funzione anche della figura del tecnico che fa parte della società ma anche del dentro. Anche quando insomma il “gesto rivoluzionario” viene dall’interno del manicomio la spinta ad esso quanto è mediata dalla figura limite del tecnico?
Senza addentrarci nella disquisizione teorica, molto interessante che Di Vittorio fa, vale la pena riflettere su questo punto per interrogarsi sulla figura del tecnico.
Che ne è stato del tecnico, dello psichiatra? Che ne è stato di quella figura che, come mostrano questi documentari, si rimetteva anch’egli alla società, tornava ad essa e alle sue esigenze. Quando questo tornare alla società significava anche tornare alla scienza laddove si era dimostrato appunto che il manicomio non aveva a che fare con essa e che anzi lì vi moriva qualsiasi possibilità di farla. Così non è solo la follia a tornare alla società, o la società a riappropriarsi della follia, bensì anche lo psichiatra, la sua scienza tornano alla società. Il suo linguaggio viene messo in crisi dall’interno per porsi nuovamente in relazione con il linguaggio della società. C’era insomma una rivoluzione sociale che stravolgeva il potere dello psichiatra ma lo restituiva al proprio ruolo. Ci si chiede quindi: che ne è stato oggi di quell’incontro tra società e tecnici, in cui ci si interrogava insieme sul tipo di percorso da seguire. Dove è finito il controllo sociale nei confronti degli psichiatri?
L’utopia della contraddizione
Si è sottolineato molte volte, non qui, la differenza tra la prassi e l’ideologia di Basaglia e il loro ruolo. C’era in lui la consapevolezza fortissima che la contraddizione non andasse necessariamente e sempre risolta ma conosciuta e accettata. Così, semplificando, la follia che torna alla società significa la contraddizione che viene accettata ed elaborata…o in attesa di elaborazione. Ma, ancora una volta, la prassi sociale verso dove è andata?
Verrebbe da dire che la società abbia cercato di assorbire queste contraddizioni, e che questo fosse un processo visibile già allora, soprattutto a livello di prassi politica.
Resta utopica insomma una contraddizione vissuta senza la tensione all’omologazione, alla giustificazione interna agli stessi meccanismi sociali. Se il folle può tornare alla società perché, nonostante le differenze, è capace, o noi possiamo aiutare ad esserlo, a vivere come noi, dove va a finire l’accettazione profonda della diversità?
Ecco che ancora una volta si mescolano, generando confusione, la follia, la salute mentale e la natura del manicomio.
Quello che forse si è perso di Basaglia, e che forse si stava già perdendo allora, è insomma questo aspetto rivoluzionario di autodeterminazione della propria dimensione individuale. L’istituzione è quella che più di tutte testimonia questo processo. Così come Basaglia già allora metteva in guardia da certi rischi parlando di istituzioni molli, oggi Rocco Canosa, presidente di Psichiatria Democratica, parla di un abbattimento di tutte le istituzioni e di un “DISSOLVERE” le psichiatrie, inteso come il loro totale superamento.
Oggi come allora lo scarto minimo è quello della nostra comprensione profonda del diverso, della profonda accettazione della contraddizione che porta la società a voler riassorbire a sé con meccanismi sempre più molli e quindi forse più invisibili una parte di realtà .
L’arricchimento più ampio che in teoria sarebbe dovuto venir fuori dall’abbattimento delle mura non è avvenuto. Non si vuole sminuire ciò che è stato fatto, tutt’altro. E’ solo che l’utopia di ieri può forse illuminarci su quanto ha detto Rocco Canosa nel settembre dello scorso anno. Egli cita prima Basaglia:
“Lo scioglimento delle contenzioni fisiche ha attualmente liberato il malato dal suo stato di soggezione alla “forza” cui, comunque, riusciva deliberatamente e personalmente a ribellarsi – attraverso i suoi “eccessi”. La libertà donatagli dal medico e dal nuovo clima ospedaliero può produrre ora in lui uno stato di soggezione ancora più alienante, perché frammisto a sentimenti di dedizione e di riconoscenza che lo legano al medico in un rapporto ancora più stretto, più infrangibile, più profondamente mortificante e distruttivo di qualsiasi contenzione fisica: un rapporto di assoluta soggezione e dedizione al “buono” che si dedica a lui, che si china – dalla sua altezza – ad ascoltarlo e non dice mai di no. Ciò non potrà che accelerare il processo regressivo che lo spingerà a sprofondare gradualmente in un morbido, indolore annientamento totale che chiamerei una sorta di istituzionalizzazione molle. Per questo il paziente continuerà a sentire la libertà, di cui avverte la presenza, come qualcosa venutagli dal di fuori, non come il risultato di una sua conquista. Così, per lungo tempo, – dopo l’abolizione delle grate da lui stesso divelte e distrutte su invito del medico – non andrà oltre il limite che gli era stato prima imposto: il disegno del cortile resta nella sua mente e la porta aperta è per lui ancora una porta chiusa”.
E poi, riprendendolo, aggiunge:
“La difficoltà di integrazione delle varie strutture tra loro, con gli altri servizi, con i soggetti attivi della comunità, che sono la conseguenza di un approccio iperspecialistico alla sofferenza, stanno riproducendo nelle strutture costitutive dei Dipartimenti gli stessi meccanismi di cronicità, di segmentazione dei bisogni e delle risposte, di esclusione soft, tipici del manicomio.
In atre parole i CSM sono sempre più ambulatorietti, servizi d’attesa scarsamente incisivi sul contesto del paziente, i Centri Diurni aree di parcheggio per persone, che tendono ad infastidire, le Strutture Residenziali abitazioni dove si sa quando si entra, ma non si sa quando si esce, i Servizi di Diagnosi e Cura repartini molto spesso con le porte chiuse e dove la contenzione fisica e quella farmacologia sono spesso la norma.
Un panorama davvero sconfortante.
Tutti questi luoghi, se non ravvivati da una nuova carica antistituzionale, diventano rapidamente le “istituzioni molli” di cui parlava Basaglia nel 1964, a proposito del manicomio umanizzato.
Sono luoghi in cui il rischio di dipendenza è molto forte, perché è alto il “potere disciplinare”, nell’accezione foucaultiana.
(…)
Sappiamo bene come i dispositivi mortificanti tipici delle istituzioni totali si riproducano anche nelle “nuove istituzioni”: imposizione della terapia farmacologia, camuffata da consenso informato, imposizione della terapia occupazionale nei centri diurni, attività di socializzazione offerte, ma molto spesso, decise dall’alto, uso indiscriminato e per lunghi periodi di neurolettici, dipendenza psicologica realizzata attraverso psicoterapie senza fine, regole rigide d’organizzazione della giornata nelle comunità- alloggio plasmano menti e corpi, assoggettandoli al potere della disciplina.
(…)
Dis-solvere le psichiatrie significa, dunque, riprendere l’attraversamento istituzionale, per decostruirne la funzione disciplinare, come abbiamo imparato proprio lavorando dentro i manicomi per distruggerli.”
Con le osservazioni di Canosa finiscono queste conclusioni, che sono più che altro alcuni spunti che lo studio ha fatto emergere. Rimane da chiedersi quale documentario potrebbe essere fatto oggi su questa realtà? Quali sono le immagini assenti di oggi? Quanto è più difficile individuare i luoghi in cui si dispiega una realtà ancora per molti versi lontana da tutti?
Per completezza, anche se esula dallo studio, si riporta qui di seguito la parte finale dell’intervento di Canosa che se no rimarrebbe sospeso in una critica vuota e di confronto col passato. Lui invece spiega cosa intende con il suo dissolvere le psichiatrie, quali prassi e quali contaminazioni culturali nuove sono necessarie oggi.
Tratto da: DISSOLVERE LE PSICHIATRIE di Rocco Canosa
“… Invece di pensare sempre ad un luogo dove depositare il matto che deve essere allontanato dalla famiglia, come la struttura residenziale, perché non attivare l’affido eterofamiliare, adeguatamente organizzato, esperienza che incomincia a realizzarsi anche in Italia?
Invece di costituire gli SPDC, in cui ancora più chiaramente si riproducono pratiche neomanicomiali di costrizione, perché non pensiamo a realizzare Centri di Salute Mentale, attivi 24 ore su 24, dotati di posti letto?
E perché quando un paziente è in crisi seria, necessariamente dobbiamo ricoverarlo in un letto di ospedale? Vi sono esperienze all’estero ed anche in Italia di gestione della crisi a domicilio, sulle 24 ore, con l’utilizzo di un team appositamente dedicato.
E ancora: dobbiamo dare sempre per scontato che le case famiglia per pazienti gravi (leggi ex lungodegenti) necessitino sempre dell’assistenza dell’operatore sulle 24 ore? Esiste l’esperienza di case autogestite, ma supportate da operatori disponibili sulle 24 ore ad intervenire in caso di necessità.
Quale è, poi, la motivazione tecnica per cui un Centro Diurno debba essere necessariamente zeppo di psicologi, medici, educatori, infermieri? Non si può pensare di stimolare l’autogestione? A dare agli utenti le chiavi del centro, così possano decidere e fare autonomamente? (A Matera lo stiamo realizzando da tempo). E perché un Centro Diurno necessita di una selezione dei pazienti all’ingresso? Di una scheda di ammissione e dimissione? Non sarebbe meglio che tutto questo tempo e queste energie gli operatori li impiegassero per favorire la contaminazione dei cosiddetti “matti” con i cosiddetti “normali”? A costruire spazi d’incontro scevro da pregiudizi, ma improntato al rispetto, all’ascolto dell’altro, semplicemente allo “stare bene insieme”, tra uomini e donne e non tra pazzi e normali?
Tutte queste cose non sono roba dell’altro mondo e le esperienze concrete dimostrano che è possibile realizzarle.
Le difficoltà che si incontrano sono due: la prima è legata al fatto che i professionisti psy non vogliono rinunciare al potere che viene loro dal ruolo: anzi i trend della ricerca, sia in campo psicologico, che in quello delle neuroscienze, sono nel solco del suo rafforzamento; la seconda dipende dagli interessi dei soggetti privati, incluso il privato sociale. Comunità, Centri Diurni, perfino assistenza domiciliare sono un buon business realizzato sulla pelle dei matti. Per questo si assiste, oggi, al rilancio delle case di cura neuropsichiatriche, ma anche al moltiplicarsi di residenze psichiatriche e strutture semiresidenziali gestite sia dal privato imprenditoriale che da cooperative sociali. Significano appalti, posti di lavoro, strumenti di costruzione del consenso elettorale da parte dei politici, come appunto erano i manicomi, che offrivano occupazione in cambio di voti.
Dis-solvere le psichiatrie significa, dunque, analizzare di nuovo come funzionano le istituzioni del controllo sociale e, pertanto, non solo quelle psichiatriche; capire concretamente da cosa e da chi è costituito il circuito psichiatrico in un territorio dato, per evitare che la presa in carico indiscriminata, da parte dei servizi di salute mentale, di una persona con disagio rafforzi lo stigma.
Dis-solvere le psichiatrie significa avere consapevolezza che da soli, come tecnici psy, non possiamo farcela. Abbiamo bisogno delle intelligenze, le più varie, delle capacità d’iniziativa, le più efficaci, dei progetti, i più articolati e continuativi, della partecipazione, la più ampia, della speranza, la più tenace.
Dis-solvere le psichiatrie significa avere il coraggio di rinunciare, sia pure in parte, a quel potere psichiatrico che vuole imporre la realtà alla follia, come accadeva nel manicomio. Sappiamo come andata: questa operazione è miseramente fallita e i matti, prima ridotti al silenzio, hanno cominciato a parlare e a reclamare i propri diritti. Ciò è accaduto nel momento in cui la psichiatria non si è più percepita come scienza che sa tutto del comportamento umano, ma ha cominciato ad aprirsi ad altri saperi e al sociale, qui nell’accezione di luogo in cui avvengono incontri e scontri, in cui i sogni entrano in collisione con gli interessi, i progetti di cambiamento con la realpolitik: insomma sociale come spazio in cui i rapporti si declinano dentro le contraddizioni.
Ciò ha reso possibile che il curante non si nascondesse dietro la maschera di chi sa bene cosa fare e il curato dietro la corazza dei suoi sintomi. L’incontro, reso possibile dall’assunzione del rischio da parte di entrambi, di perdere qualcosa, ha svelato la verità dei volti, ha favorito l’incrocio degli sguardi, ha diluito antiche paure. Non più malato e dottore ma persone, solo persone. Finalmente.”
BIBLIOGRAFIA
AA.VV., Che cos’è la psichiatria?, a cura di Franco Basaglia, Einaudi, Torino 1973.
AA.VV., Film dossier: fortezze vuote, su Altro cinema – periodico d’informazione dell’aiace, anno 1, numero 2, aprile 1976, p. 7
AA.VV., L’istituzione negata – rapporto da un ospedale psichiatrico, a cura di Franco Basaglia, Einaudi, Torino 1968.
Berlinguer Giovanni, La malattia mentale tra scienza e politica. Intervista a Giovanni Berlinguer, a cura di Albertina Seta, http://www.pol-it.org, letto e archiviato il 16/01/2005.
Canosa Romano, Storia del manicomio in Italia dall’Unità a oggi, Feltrinelli, Milano 1979.
Canosa Rocco, Oltre la salute mentale: ovvero Dis-Solvere le psichiatrie, sul sito di Psichiatria Democratica, Atti del convegno e (dis)corso ECM di Psichiatria Democratica (22) 23-24-25 settembre 2004, Cavalese (TN) – Palacongressi
Casetti – Di Chio, L’analisi del film, Bompiani, Milano 1991.
Colombo Fausto, La cultura sottile – media e industria culturale in Italia dall’Ottocento agli anni ’90, Bompiani, Milano 1998.
Colucci – Di Vittorio, Franco Basaglia, Paravia Bruno Mondatori Editori, Milano 2001.
Foucault Michel, Storia della follia nell’età classica, BUR, Milano 1998.
Nepoti Roberto, Storia del documentario, Patron, Bologna 1988.
Pitrelli Nico, L’uomo che restituì la parola ai matti, Editori Riuniti, Roma 2004.
Ridolfi Luca, La ricerca qualitativa, La nuova Italia scientifica, Roma 1997.
Tabanelli Giorgio, Il teatro in televisione – Regia e registi: dalle prime trasmissioni in diretta al digitale, Rai Eri, Roma 2003.
Vanoye – Galiot – Lété, Introduzione all’analisi del film, Lindau 1998.